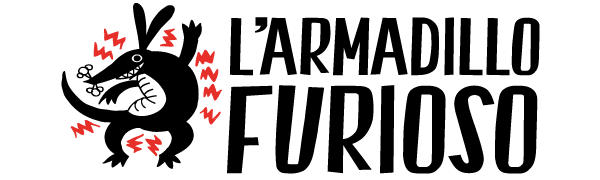Andrea Porcheddu: perché dobbiamo sempre partire dalla crisi?
Andrea Porcheddu va a teatro dal 1988, più o meno ogni sera. Ha raccontato quel che pensava su diverse testate nazionali, online, cartacee, radio e tv. Attualmente collabora con Glistatigenerali.com.
Se volessimo cominciare un’analisi della situazione di crisi culturale del teatro italiano, da quali segnali dovremmo partire? Secondo lei, la crisi del teatro potrebbe essere la diretta conseguenza di una crisi generazionale, d’identità e di opportunità? Quali sono i tempi e modi del suo sviluppo?
Ma perché, per analizzare la situazione, dobbiamo sempre partire dall’elemento della crisi? La crisi, nel nostro teatro, è solo politica e economica, non certo artistica, generazionale e di opportunità. Ogni generazione sforna i suoi talenti: il livello attorale italiano si è alzato tantissimo, abbiamo diplomati appena usciti da accademie o scuole pronti a sostenere ruoli primari; abbiamo attori e attrici che sanno essere performer, registi, interpreti, danzatori, cantanti, musicisti… Abbiamo maestri indiscussi del nostro tempo. Il teatro italiano raggiunge livelli di qualità europei: e alcuni nostri registi sono considerati imprescindibili punti di riferimento di respiro internazionale. I guai cominciano quando parliamo di gerontofilia, non solo a teatro: con pensionati che non vanno in pensione pur avendone diritto; quando parliamo di intromissione politica nelle nomine; quando cediamo alla moda del “bando”, spesso farlocco o pilotato, buono per ogni occasione. Lo sviluppo, in scena, si vede eccome: non si nota, invece, quello nella gestione pubblica di istituzioni culturali che patiscono il peso di politiche spesso ottuse o comunque, come minimo, non lungimiranti.
A fronte di molti teatri pubblici che annaspano, possiamo comunque registrare segnali positivi: la nomina di Claudio Longhi a Ert, quella di Antonio Latella alla Biennale Teatro, che vanno ad aggiungersi a Massini a Milano, D’Ippolito a Prato, Alajmo a Palermo, Mancini a Cagliari. E non voglio dimenticare la battaglia quotidiana di Antonio Calbi a Roma. Sono segni incoraggianti. Il problema, allora, è spesso il contesto, ossia la città, la regione di riferimento. I teatri italiani sono vivi e, udite udite, hanno ancora pubblico. Possono essere gestiti meglio, certo: serve disciplina in questo senso, altrimenti a pagare sono sempre gli ultimi, l’ultima ruota del carro, ossia gli artisti e i tecnici che invece il teatro lo fanno sul serio. Però, per favore, basta parlare di crisi. Le cose non vanno? Si possono cambiare. Se la categoria fosse compatta, probabilmente andrebbero un po’ meglio, no?
Si può affermare che la crisi del teatro possa dipendere anche da una mancanza di idee teatrali forti?
Questa è una domanda tendenziosa: mancano idee forti? Non mi pare. Mi sembra anzi, come accennato, che la scena italiana riesca a vivere e rilanciare sempre, nonostante tutto. Lasciamo stare i nostri artisti che spopolano all’estero, e rimaniamo in Italia: facciamo dunque l’esempio del teatro sociale d’arte, che è un settore in grande crescita qualitativa. Parliamo dell’eccellenza del teatro ragazzi, oppure del ritorno di quello che ho provato a definire “nuovo capocomicato”, ossia tutte quelle esperienze di gruppi formati da attori parigrado guidati da un attore-leader, che ha rinnovato sia l’idea di “gruppo” che quello di “teatro di regia”. L’esempio più eclatante, in questo senso, è quello di Toni Servillo, ma citerei Valerio Binasco, Arturo Cirillo, Juri Ferrini, Emma Dante, ma anche Pierfrancesco Favino e molti altri. Stanno ritrovando un rapporto sereno con il pubblico, stanno riscoprendo un modo di affrontare i classici con sapienza e immediatezza.
Qual è la funzione sociale del teatro oggi? Quali necessità soddisfa?
Non ci resta che il teatro: per incontrarci, per parlare, per commuoverci assieme. Il resto è internet. O serie Tv.
Si può credere a un rinnovamento del teatro o siamo in attesa di un modello culturale che possa scuotere le coscienze?
Il teatro non fa la rivoluzione. Non l’ha mai fatta. L’aveva capito Bertolt Brecht, che pure di politica si occupava. E il teatro, nella sua totalità, ha perso: 25 anni di tv commerciale hanno avuto la meglio su 2500 anni di teatro politico. Non c’è niente da fare: siamo una minoranza, ma siamo una minoranza attiva. “Siamo i greci di Roma” diceva Alain Touraine: mentre al Colosseo ci sono i gladiatori (allora come oggi) Seneca, Terenzio a pochi altri continuavano a far teatro. Dobbiamo ragionare nel piccolo: rifare le aiuole, come guerrilla garden.
Ma, anche qui, non possiamo far finta di niente: la minoranza (del teatro) si adegua spesso ai linguaggi della maggioranza. Ecco perché assistiamo, ormai rassegnati, all’eterno ritorno “dell’assessore”. I teatri, i festival, gli artisti hanno introiettato in fretta i dettami della riforma, adeguandosi alla domanda di numeri, ai dati, al botteghino, alle alzate di sipario. Il teatro è sempre stato sensibile all’esercizio del potere e appare chiaro che non produce più contestazione. Le forme teatrali di effettiva contestazione sono in fretta liquidate, mi viene da dire sgomberate. Quelle che restano sono sì espressioni di una minoranza, ma condivise dalla maggioranza (tollerati, sopportati). Chi protesta più, al giorno d’oggi?
Lo Stato sostiene il teatro in Italia? Se sì, ne beneficiano tutti?
Lo sostiene, certo: ma non abbastanza. Se solo si raddoppiasse il Fus – una cifra paradossalmente ragionevole pur nella crisi economica generale – molti problemi si risolverebbero e l’Italia sarebbe un po’ più all’altezza delle altre nazioni europee. La nostra è una guerra di poveri, una lotta per il penultimo posto, per prendere le briciole al banchetto degli dei. Sostengo con forza l’impegno pubblico a favore della cultura e, nel nostro caso, del teatro. Ma certo sarebbe opportuno incentivare realmente il sostegno privato alle strutture teatrali, cosa che si potrebbe fare abbastanza semplicemente, come avvenuto per il cinema.
Allora dovremmo (tutti, critici compresi) richiedere con forza un Fus adeguato al nostro tempo e al nostro Paese.
Detto questo, per arrivare alla seconda parte della domanda: no, non ne beneficiano tutti. A quale classe sociale si rivolge il nostro teatro? A che pubblico parla? Evidentemente cerca ancora solo l’elite acculturata, lo spettatore appassionato da mettere in gioco con esercizi sempre più difficili. L’animazione (o per dirla in modo raffinato, l’emancipazione dello spettatore) ha alzato il livello di impegno e di partecipazione di un pubblico sempre più divertito. Un pubblico che, comunque, ha gli strumenti per decodificare quelle provocazioni, dal momento che, nella sua gran parte se non totalità, proviene dalla minoranza colta. E si può permettere il biglietto. Il Teatro ha bisogno di clienti, di consumatori, chiamati educatamente “abbonati”. Ma una simile prospettiva esclude grandi fette di popolazione in base al censo e all’estrazione culturale. La qual cosa, peraltro, se pure rischia di scontentare l’assessore, gratifica il narcisismo delle minoranze.
Però, se il teatro parla solo alla elite, non è più frutto di quel “teatro d’arte per tutti” da cui è partita l’esperienza del teatro pubblico italiano: è d’arte, ma non per tutti. Perdendo interlocutori, non può non perdere anche il contatto con il territorio di riferimento, con l’aiuola di cui facevo cenno. La qual cosa fa sì che ci si trovi di fronte, troppo spesso, a cittadelle arroccate nel proprio splendido isolamento, dove si svolgono attività di cui la maggioranza della popolazione non è nemmeno al corrente. Ne parlavamo lo scorso mese a Vicenza, in occasione del Premio Rete Critica, riflettendo sul senso dei Festival: oggi il festival si è mutato in vetrina scintillante di tendenze, ovvero di scelte che appartengono alla elite intellettuale del futuro. Non si parla più di “direzione”, ma sempre più spesso di “curatela”, dando al momento del festival le stimmate di una mostra d’avanguardia, impregnata di scelte concettuali.
Le due misure più estreme ed urgenti da mettere in atto, secondo lei.
Una legge di settore equilibrata: che tenga conto del modello italiano e non di quello franco-tedesco; che favorisca il ricambio generazionale e di genere (non ci sono direttrici donne nei teatri nazionali); che raddoppi i finanziamenti pubblici.
Ha ancora senso mettere in scena i classici? O andrebbero “tolti di scena”?
Certo che hanno senso! Magari si tratta di pensare a un canone un po’ più ampio di quello cui siamo ormai tristemente abituati: di Shakespeare mettiamo in scena solo 4 o 5 titoli.
Si può parlare di “dittatura teatrale” nel mondo delle arti in scena? Se sì, perché?
Non capisco la domanda. Mi sembra comunque una espressione piuttosto forte. I nemici non sono sempre gli altri. E non mi sento di distinguere i buoni dai cattivi. Chi sarebbe il dittatore di turno? Ci sono state, in passato, figure dal forte carisma cui veniva riconosciuto un potere smodato nella gestione e nell’indirizzo. Probabilmente, un po’ di laicità, anche nel settore, farebbe bene. Temo di più il pensiero omologato, le cose di mode, i fenomeni, le tendenze precotte, le correnti, le “genialità” che si consumano nel giro di pochi anni.
È possibile un “teatro della crisi” in cui artisti, spettatori e critica trovino un punto in comune?
Passo.
Quant’è importante lo spettatore a teatro? Quanto è necessario investire nella formazione di un pubblico consapevole?
Adesso lo spettatore va molto di moda. Deve essere partecipe, coinvolto, animato, emancipato. Io preferisco ancora stare seduto in platea, e stupirmi per quel che vedo e sento. La questione della formazione è delicata: certo è importante formare il pubblico, farlo crescere numericamente. Ma anche qui, mi ripeto, chi formiamo? Insegnanti di scuola media con l’abbonamento, appassionate (sono tutte donne) di teatro che vogliono saperne di più? Giovani miscredenti che si annoiano? Il teatro fa bene, lo sappiamo: ma lo sappiamo noi che lo frequentiamo. E gli altri che ne pensano? Prendiamo due volenterosi medio borghesi romani che decidono di passare una sera a teatro. Escono in macchina, non trovano parcheggio, prendono un parcheggio a pagamento che costa almeno 20 euro. Entrano in teatro, pagano 35eu a testa per due biglietti. Stanno tre ore seduti. Escono, vanno in pizzeria e pagano altre 60eu, per due margherite e due birre. 150eu. E magari lo spettacolo è noioso, o di “ricerca”, o non sovratitolato, o stucchevolmente provocatorio.
Dunque a che tipo di teatro dobbiamo formare il pubblico? E perché?