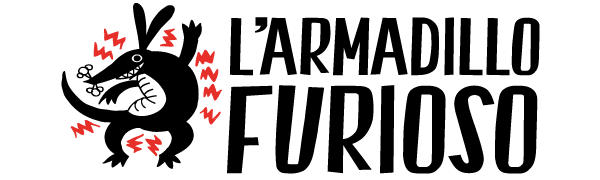Peter Brook e i misteri di Shakespeare al Napoli Teatro Festival
L’incontro con Peter Brook, uno dei più grandi registi della scena contemporanea e internazionale, ha luogo nel foyer del Teatro di San Carlo, in occasione del Napoli Teatro Festival.
Nel resoconto che segue della straordinaria serata non ripropongo alla lettera le parole del maestro, quelle tradotte simultaneamente dall’interprete, ma indugerò sul senso di alcune delle considerazioni sul teatro shakespeariano – derivate da una longeva attività di ricerca teatrale – che il regista ha deciso di sottoporre all’attenzione del pubblico del festival.
Tra i più memorabili allestimenti di Shakespeare, ad opera di Peter Brook, vanno almeno ricordati Re Lear, del 1962, Sogno di una notte di mezza estate, del 1970, specialmente per l’uso sapiente dello spazio scenico che da pieno diventa vuoto, privo di connotazioni (Lo spazio vuoto è appunto il titolo di un testo di Brook, del 1998) che da luogo rappresentativo si trasforma in luogo evocativo e magico, in spazio di contatto necessario e di scambio tra visibile e invisibile.
Nel riferire dell’incontro, partirei per prima cosa dalla descrizione delle aspettative che la lettura del programma del Napoli Teatro Festival aveva alimentato, nella sezione Laboratori, precisando la tipologia dell’intervento che il regista inglese si sarebbe apprestato a sviluppare: «Il più shakesperiano dei registi shakesperiani: Peter Brook arriva a Napoli per regalare al pubblico del Napoli Teatro Festival Italia una lezione sul Bardo».
Il pubblico in sala è perciò composto in buona parte da professionisti ed esperti di teatro, volti noti della scena senz’altro richiamati da quella seducente dicitura di “lezione sul Bardo” e dall’immenso nome di Peter Brook.
Tuttavia, a dispetto delle attese, il maestro mette subito in chiaro, con l’amabile spontaneità che lo contraddistingue, che non impartirà alcuna lezione su Shakespeare, in ragione di una insofferenza istintiva verso il ruolo del docente, e certamente – aggiungerei – in virtù dell’esigenza (innata nel Brook regista) di ricreare un piano di comunicazione autenticamente umano con il pubblico, uno scambio tra individui dal quale poter far emergere il senso della complessità e del mistero dell’opera del Bardo, certamente le sue due dimensioni più autentiche e ‘necessarie’ (per usare una sua espressione).
Non sorprende dunque l’uso di un tale tono discorsivo ad apertura di conferenza, schietto e sincero, dal momento che la ricerca di una “naturalezza” espressiva è stata per Brook un faro nel lungo cammino teatrale.
L’indagine sull’intima necessità del teatro, spirituale e antropologica, lo spinge, ad esempio, nel 1972 alla “fuga” temporanea dalle scene inglesi verso l’Africa – lontano quindi dalle istituzioni, dai modi e dai luoghi della produzione – con l’obiettivo di sperimentare, in quelle terre di piccole comunità rurali, strategie di espressione basate sull’esperienza dell’incontro e dello scambio autentico tra esseri umani: scambio di suoni, di gesti e di parole per ricreare un evento, non un prodotto estetico.
Ancora, ne La porta aperta, saggio del 1993, scrive: «Ma cosa vuol dire, allora, ‘naturale’? Naturale significa che nel momento in cui qualcosa accade non ci sono analisi né commenti; suona semplicemente vero».
Prima di affrontare i temi di Shakespeare, il maestro parla di Battlefield, lo spettacolo scritto da Jean-Claude Carrière e diretto da Brook stesso, che racconta di una guerra di sterminio fratricida tra le fazioni della famiglia dei Bharata.
Con quest’ultimo lavoro Brook torna dopo trenta anni a Mahābhārata (1985) l’opera monumentale del regista, assoluta e interculturale, tratta dall’omonimo poema epico indù e della durata di oltre nove ore, nella quale si raccontano la creazione, l’origine dell’uomo di migliaia di anni fa, e l’umanità divisa in quattro epoche, l’ultima delle quali destinata a una discesa totale verso la distruzione.
Questa grande epopea indiana, come i “trentasei testi” di Shakespeare, contiene tutti i livelli della vita, cosmici e quotidiani, metafisici e triviali: dall’ideale congiunzione degli immaginari smisurati e universali di Mahābhārata e dell’Amleto Brook prende le mosse per avviare la “questione Shakespeare”.
Per prima cosa, il maestro confessa di considerare “stupida e inutile” la domanda sull’identità storica del Bardo: sarebbe più opportuno non profanare l’area di mistero che ne avvolge le origini o comunque rinunciare a raggiungerne a tutti i costi una definizione nitida.
La stessa segretezza ne permea l’opera, irriducibile a essere afferrata una volta e per tutte.
A suo dire, sarebbe perfino sconveniente inquadrarla in una gerarchia di valori organizzata preventivamente a partire da letture critiche, da sostegni culturali di riferimento, che inibiscono attori e registi nel momento del confronto con i grandi personaggi shakespeariani: la ricerca invece, da ambo le parti (di chi interpreta e di chi mette in scena) dovrebbe riguardare ciò che anima la forma nell’opera stessa di Shakespeare, da leggere pertanto senza pregiudizi e alterazioni. La forma poi verrà da sé, mediante un lavoro di sperimentazione febbrile; altrimenti ci si illude di avere un’idea in anticipo, e si incorre invece nel rischio di una banale riduzione teatrale.
Così Brook non vede la possibilità di ricavare spiegazioni definitive e univoche dal teatro shakespeariano, che è viceversa una forma di esplorazione continua e irrinunciabile, proprio come la vita, e non ammette risposte inequivocabili o un solo punto di vista sulla realtà, ma prospettive plurime, laterali, oblique.
Bisogna avvicinarsi a Shakespeare – dice Brook, rivolgendosi agli attori e ai registi soprattutto – non con la pretesa di carpirne il mistero, con ambizione smaniosa di scoperta, ma con la speranza di riuscire a riproporne con sensibilità, anche nel presente, le situazioni dilemmatiche e i conflitti morali, per condividerli con l’umanità di ogni tempo: nessuno come lui ha mostrato con altrettanta straordinaria vividezza l’intima ‘conflittualità’ della coscienza.
Nel suo teatro dunque coesisterebbero, a detta di Brook, tutti i livelli dell’esistenza e tutti gli stati dello spirito umano: potere, ambizione, invidia, passione sono i gradini di una lunga scala da salire, al culmine della quale è quasi impossibile non provare vertigine e senso del vuoto: a noi spettatori pertanto è dato scalare quei livelli, pressappoco simili alle cornici del purgatorio, e guardarli dall’alto, come sporti da differenti altezze di un grattacielo (la metafora è sempre di Brook).
Nel punto più alto dell’edificio si abbraccia con lo sguardo lo spettacolo dell’umanità intera, nelle sue quotidiane vicissitudini e traversie.
Nel documentario Peter Brook: la sua esperienza teatrale, visibile su “Rai Scuola”, il regista afferma: «Se pensiamo che il teatro debba rivolgersi a generazioni diverse e che questo sia il modello datoci dal teatro sanscrito o da quello elisabettiano, bisogna che i grandi cercatori di verità, i ladruncoli e i bambini possano condividere la stessa esperienza».
L’arte del teatro è esperienza che fluisce di continuo tra i confini di realtà e immaginazione: attraversarli vuol dire trasfigurare il mondo, come fanno i bambini, che vedono in un manico di scopa un altro mondo possibile: un cavallo, una spada.