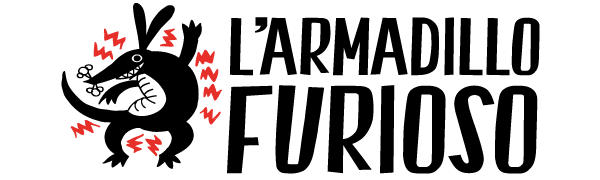Jeff Buckley: la discografia
Jeff Buckley è famoso soprattutto per la cover di Hallelujah di Leonard Cohen ma, in realtà, è stato un cantautore sopraffino. Vi presentiamo la discografia imperdibile scritta, tanti anni fa, da Alessandro Mattiuzzo, Pasquale Boffoli e Luca D’Alessandro per Musicboom.
Live at Sin-é (1993)
“This is a song about a dream”, recita la voce indolende di Jeff Buckley prima di Mojo Pin, canzone posta in apertura di Live at Sin-é. All’uscita di questo live, anticipazione del capolavoro Grace, il giovane Buckley è ancora uno sconosciuto dalla voce meravigliosa. I quattro brani contenuti in questo mini lo fotografano da solo con la sua chitarra in un live acustico che la prontezza manageriale di “Mother Mary Guibert” pianifica di pubblicare presto nella sua interezza.
Quattro canzoni, per ora, quattro classiche gemme di perfezione vocale, di sensibilità, di emozione concreta, contornate da una tecnica di arpeggio chitarristico spesso imprecisa e forse proprio per questo ancora più “vera”. Buckley è qualcosa sopra tutto, qualcosa di inarrivabile, una stella esplosa all’improvviso proprio da questo concerto impresso su traccia laser e destinata a splendere per sempre.
Vita eterna, Eternal life, qui in una versione più “bluesy”, ovviamente meno irruenta rispetto a quella contenuta nell’esordio su lunga distanza, eppure altrettanto “piena”, intensa, magica, con quegli echi a metà tra il grunge di Seattle e gli echi psichedelici post-Hendrix.
E poi le covers. Jeff Buckley era un maestro, nello scegliere e interpretare i brani altrui. Qui compaiono la splendida Je N’en Connais Pas La Fin, tratta dal repertorio di Edith Piaf, resa con un’atmosfera da “crepuscolo in un lunapark in chiusura”, triste e allo stesso tempo sognante e speranzosa. Bellissima.
E The way young lovers do, scritta da Van Morrison, interpretata con una verve puramente rock’n roll, magari infarcita di virtuosismi vocali eccessivi (ma che Buckley poteva permettersi eccome!), qui diventa una sorta di appendice di Eternal life, per groove e fisicità, quasi ossessiva nella ripetizione del ritornello.
E’ tutto qui, chiuso in 4 canzoni. Poco da aggiungere, per commentare questo disco. Certamente un manifesto incredibile, testimonianza eterna di un concerto a cui in molti non hanno avuto la fortuna di poter assistere, purtroppo.
Grace (1994)
Correre nella notte, in auto, da solo, con la spia della benzina che ti fa l’occhiolino e i lampi di quel forte temporale che illuminano la strada. Un canto ti accompagna e lascia andare la tua anima tra quegli improvvisi fasci di luce a combattere la pioggia violenta che, schiaffeggiandola forte, tenterà di lacerarla. Non riuscendoci. La sentirete, invece, librarsi in volo come l’immensa voce dell’anima malinconica di Jeff Buckley: un antro di cristallo in cui ogni eco si fa musica e in cui la luce è densa di promesse.
Ed è lì, insieme a quelle mille gocce di pioggia che il tergicristallo fatica a lavare via, che si mischieranno le tue lacrime. Quelle lacrime che diventeranno cerchi concentrici sulla superficie del Mississippi.
Grace è un’emozione, un malinconico mondo in cui rifugiarsi, un tenue viaggio fra sensazioni gentilmente schizzate a matita. Unica vera eredità di un’artista, la cui angoscia diveniva arte, il cui dolore si tramutava in canto, la cui rabbia, come lingua di fuoco, bruciava in petto furiosa.
Liquida, la voce di Buckley, si risveglia dal torpore in Mojo Pin e chiama il suo amore in Grace. La luna sta chiamando. Ma le nuvole ovattano la sua voce.
Con Last Goodbye il pensiero vola leggero alla donna che sul sedile vuoto di fianco al tuo non siedera più. E ti si strozza in gola il bisogno di quel bacio. E ti senti più solo. Come ieri sera in quel tuo mesto e solitario brindisi di Lilac Wine, con la sigaretta che ti guardava dalla ceneriera di vetro, nella quale sapeva di dover morire assieme ai pensieri di quel momento.
Sembra un sogno questo muro di pioggia, eppure è tutto So real. L’amore perduto, l’angoscia e la paura di amare. Ti affidi ad una preghiera: Hallelujah e la fede vogliono darti quella speranza che troverai in Lover you should’ve come over. La fiamma dell’accendino fotografa un timido sorriso e il fumo che avvolge il tuo viso lo fa apparire più sereno. Hai voglia di cantare e lo fai. Cantare liberando la tua anima. Corpus Christi Carol è il tuo sfogo, smette di piovere e la luna fa capolino.
Ti guarda e ti sorride. Si, ce l’ha con te. Ti sussurra di Eternal Life. E allora nulla più fa paura. Spingi sull’acceleratore senza temere l’asfalto ancora bagnato, senza curarti del fatto che la spia della benzina abbia improvvisamente deciso di smettere di farti l’occhiolino per cominciare a guardarti fisso. Ma niente fa paura adesso e vuoi solo tagliare l’aria umida di questa notte. Che sembra non voler finire.
Sospesa e prosperosa la luna ti ricorda il seno di una giovane a cui volentieri tormenteresti i capezzoli. Pensi ad una foto. Dream Brother lascia rincorrere flash: labbra, sorrisi, lacrime. Lacrime. Cerchi concentrici sulla superficie del Mississippi.
Resta la luna e un dolce canto. Udendo il quale anche lei non può che sciogliersi in un silenzioso pianto…
Live from the Bataclan (1996)
In terra francese il giovane Buckley è a suo agio. Anche questo disco è testimonianza di un concerto. Ma Grace ha già cominciato a mietere vittime tra i cuori degli appassionati di musica, e quando la band attacca l’incipit di Dream brother c’è molto più entusiasmo nel pubblico, rispetto al concerto del Sin-é. E c’è molto più pubblico.
Lui, però, è sempre lui. Con gruppo e senza. La sua voce e la sua persona sono i protagonisti, tutto il resto è bellissimo contorno.
Dream Brother è sospesa, onirica, poi cresce, la voce trema, un’apertura spaventosa, e l’onda, inarrestabile, la musica perfetta, colpisce il ragazzo in prima fila come quello che con le cuffiette cerca ancora di vivere l’emozione attraverso un CD.
C’è l’arte suprema in ogni acuto di Jeff Buckley.
The way young lovers do (12 minuti di voce e chitarra) viene accompagnata dal battere di mani del pubblico. C’è “presenza” fisica di amore che da Jeff va al pubblico e ritorna. La resa è migliore, rispetto alla versione del “Sin-é”. La voce più tesa e controllata, come i vocalizzi “skat”, la chitarra più precisa. E particelle di arte nell’aria.
Anche Je n’en connais pas la fin, in medley con Hymne l’amour (entrambe cantate un tempo da Edith Piaf) viene accolta con un boato del pubblico. Jeff sa conquistare la sua platea. Voce e chitarra, ancora. Poi addirittura solo voce. E non si sente la mancanza di alcunchè.
Chiude Hallelujah, cover di Leonard Cohen, e non si può descrivere a parole quello che si sente. Potrei allegare un mp3 alla recensione, se non fossi sicuro di finire sotto gli strali di Mamma Guibert. Posso ripetere sempre gli stessi concetti sulla precisione, sulla concretezza, sull’eternità, e non dire niente…
Jeff Buckley dal vivo è la cosa migliore che avrebbe potuto capitare ad ognuno di noi. Avrebbe potuto.
Sketches (For My Sweetheart the Drunk) (1998)
La travagliata genesi di Sketches (From My Sweetheart the Drunk) non toglie nulla alla grandezza ed all’immenso carisma di questo lavoro che molti considerano il vero e proprio testamento spirituale
troppo, troppo prematuro di un artista dotato di un’emozionalità umanissima ma al contempo esasperata ed allucinata.
La storia é già leggenda: il materiale (registrato dopo l’immenso Grace) che doveva essere il secondo capitolo discografico di Jeff, prodotto da Tom Verlaine, non soddisfa l’inquieto songwriter ed i nastri già pronti imboccano la strada ‘maledetta’ di Memphis, dove Buckley si reca per rivedere il tutto nella primavera del ’97. Una quantità di home-demos vedono la luce nella città di Elvis, ma il 29 maggio quel dannato ‘muddy Mississippi’ strappa Jeff alla vita, a noi ed alla sua arte visionaria che stava lievitando verso
altitudini sbalorditive. Mamma Mary Guibert e alcuni discografici decidono di non lasciar dissolversi nel vento e deteriorarsi tra la polvere nei cassetti gran parte del prezioso, superbo nettare creativo che Jeff ha registrato in quel periodo travagliato: il tutto é pubblicato dalla Sony un anno dopo la sua morte in Sketches..una doppia raccolta. Arte visionaria dicevo; gli esempi sono eloquenti in queste registrazioni che possiedono il fascino di una produzione casalinga non rifinita : la concitata bassa fedeltà di Demon John, Your Flesh Is So Nice, Back in N.Y.C. (incredibile psichedelica rilettura di un brano dei Genesis da Lamb Lies Down On Brodway), la solitudine vocale (e gli echi arcani) di You And I, una straziante preghiera d’amore scagliata nel vuoto… di un’intensità senza precedenti, l’ansia incalzante dell’avventurosa Nightmares By The Sea, le sontuose cattedrali elettriche di The Sky Is A Landfill, Haven’t You Heard dove si manifesta l’amore di Jeff per bands storiche conme i Led Zeppelin.
Ma a colpire sempre é quell’inarrestabile senso di dolore e di angoscia che filtra dalla sua voce languida come poche, da queste interpretazioni in cui le tempeste del subconscio sono protagoniste inquietanti di un’ispirazione oscura e tragica : brani come New Year’s Prayer, Vancouver, Witches’ Rave, Morning Theft annegano in questo pessimismo cosmico. Delicatezza e sensualità morbose e commoventi grondano invece da Opened Once, I Know We Could Be So Happy…, la soulful Everybody Here Wants You, Jewel Box, e la folkeggiante Satisfied Mind, un classico ripreso nei sixties anche dai Byrds di Turn Turn Turn. Sketches può cambiarti dentro con la sue intuizioni estetiche…di quanti dischi si può dire lo stesso?
Mystery White Boy (2000)
Mystery White Boy é l’emozionante documento live dell’omonimo tour mondiale che Jeff Buckley e la sua band tennero tra il ’95 ed il ’96 a supporto di Grace.
Sono spezzoni di concerti australiani (Melbourne, Sidney), europei (Francia: Lione e Parigi / Germania: Amburgo) ed americani (Seattle, San Francisco) accuratamente selezionati ancora una volta dalla madre Mary Guibert in collaborazione con i membri della band di Jeff, Michael Tighe-guitars, Mick Grondhal-bass e Matt Johnson – drums. Dopo un estenuante ascolto dei nastri dei concerti sono stati scelti i momenti trascendentali delle singole esibizioni – sono parole della Guibert – che rendessero giustizia alla magia, all’anima e all’abilità nel catturare l’audience che Jeff infondeva nelle sue interpretazioni live.
Il risultato é pienamente raggiunto: i brani tratti da Grace, Dream Brother, Mojo Pin, Grace, Eternal Life, Last Goodbye risultano notevolmente induriti strumentalmente, dalle fattezze quasi grunge, sino
a punte di noise catartico. Stupefacente la duttilità vocale di Jeff, che passa da registri lirici/recitativi e falsetti sublimi a toni aspri ed esasperati: nitidissimo viene in queste registrazioni nuovamente a galla un fil-rouge tra il suo approccio ‘totale’ allo strumento voce e l’allucinata espressività del padre Tim! Il massimo dell’esasperazione rockistica é raggiunto nelle trascinanti versioni di Eternal Life, Grace e Mojo Pin nelle quali la band sfoggia sempre uno stordente suono d’insieme avulso da solismi. Le alcooliche Lilac Wine e Moodswing Whiskey esaltano invece quel mood da chansonnier-sfaccettatura mercuriale del versatile Jeff che trionfa nel ‘Live At Sin-é’ uscito nel ’94, Hallelujah/I know it’s over (medley) cover di Leonard Cohen é un capolavoro mistico di concentrazione vocale. Toni da consumato crooner nell’altra cover di Gershwin, The Man That Got Away ed ancora un brano di Alex Chilton (Big Star), Kangaroo, afferrato e dilatato attraverso dieci minuti frastagliati.
Live at L’Olympia (2001)
Quando esce questo live, Jeff se n’è già andato da 4 anni, ed è già cominciata (con Sketches e Mistery white boy) quell’opera di ripescaggio di inediti e versioni dal vivo operata dal team condotto da sua madre.
Il prodotto in questione non aggiunge moltissimo a ciò che già aveva donato Mistery white boy e a ciò che si poteva estrarre già dal Live at Sin-é e dal Live from the Bataclan. Un altro concerto su territorio francese, un’altra folla in delirio per la migliore voce degli ultimi 20 anni.
Qualche valore aggiunto, però, a cercare bene…
La cosa migliore è una inaspettata vena comico-ironica di Jeff, che prima di Dream Brother scherza in francese col pubblico, e poi si fa serio dicendo: “questa è la prima canzone che abbiamo scritto insieme”.
Segue una irruentissima Eternal life, quasi a scaricare quintalate di rabbia repressa, a tratti sembra di sentire gli Zeppelin, o gli Aerosmith. E ancora più cattivo, Jeff si lancia in Kick out the jams, cover degli MC5 eseguita con una verve casinara che neanche l’originale…
E poi le altre: le dolcissime Lilac Wine, Je n’en connais pas la fin e Hallelujah; e Grace, capolavoro su tutte.
E un bellissimo inedito: That’s all I ask, preso da Nina Simone. Ecco, questo da solo vale il CD, quello che Jeff aveva ancora da dare è racchiuso dentro questa cosa bellissima, per la quale lui chiede scusa, all’inizio.
Poi una versione-beffa di Kashmir (Led Zeppelin). Si ride e si piange, durante questo concerto.
Chiude il tutto una What will you say presa da un altro concerto (il Classical Festival) e impreziosita dalla partecipazione di Alim Qasimov).
Non so dire se veramente questo materiale meritasse la pubblicazione (pur racchiusa in un lussuoso digipack ben curato), vista la resa sonora non eccelsa, e se con Jeff in vita sarebbe stato reso pubblico… ma è sempre un piacere riascoltarlo (e questa è l’arma di cui dispone la crew di Mary Guibert, si sa).