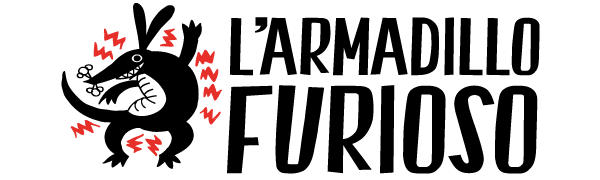Queen: discografia dettagliata
Queen (1973)

Per apprezzare questo disco, cercatelo nella edizione americana della Hollywood Records: “Queen” è già da par suo un gran bel debutto, ma i brani aggiuntivi che propone la label americana (Mad The Swine, Keep Yourself Alive long lost re-take version ed il remix ben fatto di Liar) rappresentano la ciliegina su una torta gustosa.
I Queen, con questo loro primo disco, mostrano di avere le carte in regola per fare le cose per bene: pur con alcune inevitabili ingenuità (Son & Daughter, Jesus), May, Taylor, Deacon e Mercury stabliscono il proprio sound (Keep Yourself Alive), lo infarciscono di orpelli funzionali e godibili (The Night Comes Down), donano ai propri brani una dimensione onirica e fiabesca anche nei testi (My Fairy King).
“Queen” è aggressivo e dolce, pacato e fulminante: c’è fin troppa carne al fuoco (tant’è vero che il primo abbozzo di Seven Seas Of Rhye verrà ripreso ed ampliato a dovere nell’album successivo), ma la band dimostra di saper divertire senza stancare, dandosi un tono ma prendendosi anche volentieri in giro (Great King Rat). Il grosso del lavoro compositivo è opera di May e Mercury, e tale rimarrà per altre future releases, ma in fase di assemblaggio sonoro i quattro si dimostrano coesi e volenterosi, battendo molte band più avanti di loro in fatto di autoregolamentazione e professionalità. Un buon inizio.
Carlo Crudele
Queen II (1974)
“Queen II” mantiene una solida affinità stilistica e formale con l’album d’esordio, proponendosi sin dal titolo come il suo ideale “sequel”. Il disco segna anche una decisa maturazione artistica della band, capace ora di consolidare i propri tratti assumendo connotazioni più marcate e personali.
L’adesione al movimento glam appare qui stemperata da forti ascendenze riconducibili ancora ai Led Zeppelin, eppure le composizioni di Mercury tratteggiano uno stile originale e sostanzialmente inedito. La produzione talvolta minimale e il missaggio sempre scadente non scalfiscono melodie evocative come White Queen o Father To Son, solido pezzo rock che evidenzia le qualità di May nel songwriting, né inibiscono la creatività di un Freddie in evidente stato di grazia.
L’atmosfera favolistica evocata dalle validissime Ogre Battle o Seven Seas Of Rhyie (privo vero hit del gruppo) trova un seguito nella meravigliosa The Fairy Teller’s Master-Stroke e in The March Of The Black Queen, che sottlinea la curiosa spaccatura tra la prima parte del disco, da addebitare principalmente al chitarrista, e l’altra, contrassegnata esclusivamente da brani di Mercury (in luce grazie anche ad episodi più leggeri come Funny How Love Is).
I prefissi white e black definisono inoltre una sorta di mitologia personale intuibile tanto dalle liriche quanto dalla nota immagine di copertina; le incognite risiedono invece nel sound di The Loser In The End, sciatto rock’n roll firmato da Roger Taylor in veste di cantante.
Uno sfoggio di esuberante inventiva per un piccolo classico.
Marco Iannini
Sheer Heart Attack (1974)

Basterebbero le due versioni di In The Lap Of The Gods a confermare le straordinarie doti compositive di Mercury, ma “Sheer Heart Attack” regala molto altro.
Meno viscerale e autentico dei precedenti album (a dispetto del titolo), forse non altrettanto ispirato sul piano melodico, il disco si fregia comunque di una produzione superiore, nonché della partecipazione attiva di Taylor nella trascurabile ma ironica Tenement Funster e di Deacon, all’esordio da songwriter con la lieve Misfire.
Notevoli le sferzate “hard” proposte da May in Brighton Rock e Now I’m Here, brano amatissimo dagli hardcore fans, ma sono firmate da Freddie l’arcinota Killer Queen, la soffice Lily Of The Valley e la bizzarra Bring Back That Leroy Brown, capaci di lasciare il segno per la carica quasi “esotica” che sprigionano, il fascino evocato dalle liriche e il sostrato corale in accompagnamento alla voce di Mercury.
L’energica Flick Of The Wirst e l’ipnotica She Makes Me, una ballata dal sapore vagamente “Beatles”, coronano un album che irrobustisce la tendenza dei Queen alla forma-canzone più tradizionale, svelando però anche una “maturazione” della band in senso commerciale.
Marco Iannini
A Night At The Opera (1975)

Il salto di qualità definitivo avviene con il quarto album, capace d’imporre all’attenzione generale un capolavoro del calibro di Bohemian Rhapsody, confermando inoltre l’impeccabile personalità stilistica della band.
Benchè mostri il fianco sulla lunga durata, “A Night At The Opera” può annoverare perle d’indiscutibile fascino come Lazing On A Sunday Afternoon e Seaside Rendezvous, entrambe mosse da un inequivocabile verve ’50s, accanto all’incedere schizofrenico e progressive dell’imponente The Prophet’s Song, capace di esaltare in oltre otto minuti le discrete qualità tecniche di May alla chitarra.
La varietà del disco non valica mai i confini della coerenza formale, come sintetizzano egregiamente la rabbiosa Death On Two Legs, pezzo dedicato all’ex manager del gruppo, e la distensiva Good Company. Ancora negativa la prova di Taylor in veste di songwriter nell’imbarazzante I’m In Love With My Car, mentre brilla il pop sincero di Deacon che firma il singolo You’re My Best Friend; trascurabili poi la melenza Love Of My Life e l’inutile ballata ’39. Chiude infine un riadattamento elettrico dell’inno inglese, sottoforma di ironico omaggio alla Regina.
Tutto sommato sopravvalutato, per certi versi imprescindibile.
Marco Iannini
A Day At The Races (1976)

E’ l’eterna storia del “cosa facciamo dopo”: per la Regina la notte all’opera era stata quantomai benevola, ma adesso bisognava tirare fuori dal cilindro qualcosa di altrettanto scintillante. “A Day At The Races” è la risposta del quartetto: articolata, interessante e sfaccettata, pur se chiaramente non all’altezza della release precedente.
Si torna alla più classica forma canzone, limitando le contaminazioni stravaganti (e durature) che avevano fatto di Bohemian Rhapsody un gran successo, ma i fronzoli poetici di Mercury rimangono evidenti punti di forza. Si danno da fare anche i comprimari Taylor e Deacon in fase di songwriting, con buoni risultati, ma anche qui è ovviamente da May e Mercury che arrivano i momenti migliori, con una equa divisione degli ambiti che esplicita maggiormente quanto l’uno sia il completamento dell’altro.
Si parte con Tie Your Mother Down, rock arrabbiato che si conquisterà un posto nel cuore dei fans (e delle classifiche), ma i brani migliori sono altri: l’arcinota Good Old Fashioned Lover Boy, apoteosi dell’estetismo mercuriano forte di un testo frizzante che gioca con arguzia su amore e sessualità, o la conclusiva Teo Torriatte (Let Us Clin Together), nella quale il gruppo palesano tutto il proprio amore per la terra del Sol Levante in uno struggente brano dotato di un bridge da antologia.
Ma non tutto fila per il verso giusto: White Man è decisamente fiacca, You Take My Breath Away risulta un po’ autocompiaciuta (ma non per questo disprezzabile) e Long Away vede May pericolosamente sbilanciato verso quel pop insipido che tanto nuocerà, molti anni dopo, alla sua carriera solista.
In generale, comunque, la prova della band rimane di tutto rispetto: il fatto che “A Night At The Opera” fosse più ispirato non deve certo spingere a sottovalutare questo interessante sequel.
Carlo Crudele
News Of The World (1977)

“News Of The World” uscì alla fine degli anni ’70, in bilico tra il rock dei Seventies e la discomusic che stava per fare sfracelli tra i palinsesti radiofonici di mezzo mondo: gli undici brani presentati dai Queen nella loro “prova del fuoco” in studio si spartiscono equamente i compiti, portando ad un disco sfaccettato ma frammentario.
I colpacci classici della band ci sono tutti: pur volendo lasciare da parte l’iniziale duetto We Will Rock You / We Are The Champions, da allora ripreso in tutte le salse per vent’anni di successo assicurato, ci sono Spread Your Wings, It’s Late e Sheer Heart Attack che valgono da sole il prezzo del biglietto.
Ma il rock compatto e radio-friendly di questi brani si stempera poi in mille altre vie che disgregano l’album: Get Down Make Love sembra, nonostante il successo che ebbe all’epoca, un becero groove da dancefloor, mentre Sleeping On The Sidewalk è un bluesaccio solo decente dove la voce educata di May abbassa il punteggio di molti punti.
Però c’è di che gioire, soprattutto per il lavoro congiunto e inedito della coppia Mercury/Deacon (Who Needs You) e per la commovente ballata pianistica finale (My Melancholy Blues) composta da un Freddie in stato d’indubbia grazia. Completano il tutto alcuni dignitosi riempitivi (Fight From The Inside, It’s Late) e una All Dead All Deadnostalgica e un po’ prevedibile.
Carlo Crudele
Jazz (1978)

Del precedente “News of the world” e dei suoi inni da stadio rimane poco o niente. Straordinariamente spiazzante e altamente ritmico è stato un album che ha tracciato, in qualche modo, un solco con il più recente passato preferendo la cura della tecnica all’impatto e al trasporto della semplicità.
E’ un disco molto suonato e che abbraccia sonorità nuove e dal quale evince in maniera sorprendente l’apporto di John Deacon che forse, per la prima volta, ha provato ad imporre la sua personalità ed il suo strumento. Riuscendoci.
Oltre alle ben note Fat bottomed girls e Bicycle race, genialmente collegate tra loro fin dalla copertina, il lavoro riserva altre piacevoli sorprese. Si va dalla spiazzante apertura affidata a Mustapha a dolci ballate quali Jealousy e In only seven days passando per brani dall’alto tasso di coinvolgimento come If you can’t beat them e Let me entertain you.
Trova spazio anche il rock ‘n roll: quello duro e tagliente di Dead on time e quello più pacato e venato di blues di Dreamer’s ball. Senza dimenticare l’incalzante Don’t stop me now, a tutt’oggi uno dei brani più belli scritti dai Queen e che fotografa un Mercury in forma smagliante.
Da avere assolutamente.
Luca D’Alessandro
The Game (1980)

Insieme a “A night at the Opera” è stato, dal punto di vista delle vendite, uno dei dischi più fortunati per il gruppo inglese. Si tratta comunque dell’unico punto di contatto con quell’album, visto che The Game risulta diametralmente opposto al capolavoro del 1975 non solo per concezione ma anche per le inedite sonorità esplorate.
I quattro inglesi maturano ulteriormente il sound di “Jazz” e sperimentano nuove soluzioni che li avvicinano straordinariamente tanto al funky-rock (Dragon Attack), alla disco-soul (Another one bites the dust) quanto al rockabilly (Crazy little thing called love).
“The Game” mette in fila una straordinaria sequenza di hit; oltre alla title-track spiccano l’indimenticabile Save me, l’energica Rock it, la sorprendente Don’t try suicide, la spensierata Need your loving tonight.
Tutto l’album suona compatto ed omogeneo e lascia ampio spazio alle sperimentazioni non solo di carattere musicale ma anche tecnologico; per la prima volta in questo disco, infatti, i Queen provano i sintetizzatori e l’effetto è straordinariamente incoraggiante al punto da produrre un grosso seguito anche in America, da sempre un po’ restia a colonizzazioni musicali.
Un disco capace di fermare il tempo.
Luca D’Alessandro
Flash Gordon (1981)

Oltre che colonna sonora del film omonimo, “Flash Gordon” è ritenuto a tutti gli effetti una pubblicazione discografica dei Queen.
Il risultato è in linea di massima buono, sebbene non esaltante; la maggior parte del lavoro è strumentale e i dialoghi del film si dividono non molto equamente le parti con il cantato di Mercury. Tuttavia, sono proprio i brani più orientati alla forma canzone, che rappresentano gli episodi migliori dell’album. A parte la nota Flash’s Theme è infatti imperdibile la conclusiva The Hero, in cui il quartetto inglese sembra sperimentare addirittura ammiccamenti al progressive.
Nota di menzione meritano anche Football fight, The weeding march e Vultan’s theme. Il tutto è piacevole, ma quando alla musica vengono sottratte le immagini e le ambientazioni per la quale è stata pensata, si assiste ad un calo repentino di longevità.
Luca D’Alessandro
Hot Space (1982)

Prima di passare definitivamente al rock fm di “The Works”, i Queen si prendono una vacanza dalle loro sonorità classiche per dar vita ad un inedito album in bilico tra funky e soul. “Hot Space”, che esce nel 1982 per la consueta EMI, viene però oscurato dal fortunato singolo Under Pressure, cantato in coppia con David Bowie e bollato frettolosamente come insulso.
Riascoltandolo dopo vent’anni si conviene che, pur non essendo sicuramente un disco eccelso, il lavoro aveva i suoi bravi punti di forza: il completo cambio di matrice non fu indolore, ma mostrò la stoffa dei quattro, che vollero probabilmente evadere dal cliché che si erano andati creando con le ultime fortunate produzioni.
“Hot Space” è sostanzialmente un disco altalenante, che vive di alti e bassi: se sono insostenibili i richiami pseudosessuali di Body Language (ovvero un Mercury in preda a discutibili crisi erotomani) e Calling All Girls è solo un buon riempitivo, ci sono piccole perle come Life Is Real e Back Chat che è difficile lasciare a terra. Da segnalare, comunque, che il cuore dell’album rimane ovviamente rock: pur costruiti su grooves contagiosi di basso, i due brani centrali (Action This Day e Put Out The Fire) sono rock puro, magari un po’ più pulito del solito.
Traccia chiave dell’album è Cool Cat: un pezzo decisamente sottovalutato di soul compatto e solido, con un ottimo falsetto di Mercury ed un Deacon finalmente in risalto. Da recuperare.
Carlo Crudele
The Works (1984)

“Hot Space”, quale che sia il giudizio vent’anni dopo, non fece una bella figura nelle charts dell’epoca, e i Queen volevano leclassifiche. Per cui, alla faccia delle “nuove idee” che nelle interviste attribuivano al loro nuovo fonico Mack, dopo un paio d’anni i quattro fecero uscire “The Works”. Il colpo gobbo della loro carriera, il punto di svolta: i nove brani dell’album servirono ad ampliare enormemente il pubblico della band, che con questo disco viravano decisamente verso il rock fm più prevedibile, cambiando pelle una volta ancora e disponendosi finalmente a favore dei riflettori e dello showbiz più becero.
Solo che stavolta la pelle nuova era decisamente peggiore della precedente, e non furono pochi i fans della prima ora che storsero il naso: pur tuttavia, quasi tutti i pezzi si rivelarono sistematicamente degli hits inequivocabili, e l’lp si insediò ai primi posti delle classifiche europee per molti mesi.
Nello sconcertante vuoto cosmico di anthems insipidi quali Radio Ga-Ga o Tear It Up, risaltano comunque gli episodi forse meno conosciuti del disco: Man On The Prowl è un bel rock-blues Elvis-style con tanto di assolone finale e Keep Passing The Open Windows ha il lirismo e la melodia che solo Mercury riusciva a garantire.
Per il resto, solo lo stile ed una voce come sempre ineguagliabile salvano Hammer To Fall ed It’s A Hard Life: i brani rimanenti, compresa la melensa e sopravvalutata Is This The World We Created…?, sono paccottiglia degna di una raccolta di timide b-sides.
Se proprio dovete acquistare quest’album, cercatene la versione americana della Hollywood Records: oltre a due consueti e sonnolenti remix, troviamo in coda ai brani una I Go Crazy immediata, sfrontata ed ingiustamente esclusa.
Carlo Crudele
A Kind Of Magic

Ha il sapore dell’evento l’uscita di “A Kind Of Magic”, disco in grado di svelare le mille risorse creative della band inglese, nonchè colonna sonora del fortunato film Highlander.
Il sofisticato apparato produttivo allestito da David Richards regala i suoi frutti migliori nelle popolarissime One Vision e Friends Will Be Friends, senza dimenticare la raffinatezza pop della title track, oltre all’efficacia melodica di One Year Of Love.
Who Wants To Live Forever rappresenta poi un indiscutibile gioiello cui fanno da contrappeso la desolante Pain Is So Close To Pleasure, pericolosamente affine alle prove in studio degli Wham, e Princess Of The Universe, incapace di replicare l’irresistibile aggressività ostentata da Gimme The Prize.
Davvero evocativo il finale contrassegnato dal ritmo incalzante di Don’t Lose Your Head assieme alle tracce strumentali inserite nelle versioni rimasterizzate EMI.
Marco Iannini
The Miracle (1989)

Con “The Miracle” il declino non è mai stato così roseo.
Sembra un perverso slogan pubblicitario, ma in realtà l’album è davvero frutto di una tale contraddizione: i Queen, all’apice del loro successo internazionale, chiudono il Live Magic Tour a Knebworth, in uno stadio stracolmo per due serate consecutive. E stravincono tutto, fiaccando altisonanti record di vendita e gradimento, divenendo nel giro di pochi anni più popolari dei Beatles (e conseguentemente, stando alle parole di Lennon, di Gesù Cristo): ma la notizia che Mercury è malato di AIDS ha già sconvolto i piani della band, per cui quel concerto sarà l’ultimo della loro storia.
Si concentrano quindi sul lavoro in studio, dopo una meritata vacanza di qualche anno, ed il risultato è strabiliante: il nuovo disco risulta Miracoloso sin dalla grafica, innovativa per l’epoca, che li presenta uniti in un unico volto sorridente.
C’è molto da notare in The Miracle: le cose sono cambiate e si vede. Non potendo essere più animali da palco, i quattro si trasformano in borghesi di classe: le foto cominciano ad essere stilose, i colori più raffinati. Si esalta lo spirito di corpo: tutte le tracce sono firmate dal gruppo e non più dai singoli componenti, anche se il songwriting dei quattro è così differente che le appartenenze saltano all’occhio. Insomma, si fa quadrato: ed è forse l’improvvisa spada di Damocle della malattia che li spinge a realizzare un album così bello e gratificante.
“The Miracle” mostra una gradita omogeneità di fondo: escludendo Party, introduzione diretta e sferragliante, tutti i brani –compresi quelli più tirati- hanno un che di sfarzoso ed elegante. Ogni canzone è una gioia per le orecchie, con il mixaggio che esalta le capacità di una band mai in tale spolvero: ascoltate la title-track, I Want It All o Breakthru per capire quanto i membri appaiano coesi ed asserviti alla realizzazione di un album corale.
Anche gli scantonamenti verso strade poco battute riescono egregiamente: My Baby Does Me sembra riprendere il soul di “Hot Space” con maggiore credibilità, mentre Rain Must Fall si tinge di un curioso pop-blues fresco e solare.
Il capolavoro finale è “Was It All Worth It”, bissato dall’ottima bonus track Hang On In There: anche qui si rasenta la perfezione, con testi mai scontati e dolorosamente aderenti ad una realtà di cui pochi conoscevano i reali contorni.
Carlo Crudele
Innuendo (1991)

L’ultimo disco della band: da qui in poi cominceranno le speculazioni, e saranno troppe anche per chi li ha visceralmente amati nel corso dei due decenni vissuti da protagonisti.
I Queen lasciano il campo col botto, consapevoli della loro situazione e decisi a dare alla luce un album epico, da iscrivere senza dubbio negli annali della musica: sempre invisi alla stampa musicale, spesso sottovalutati dai critici, Mercury e compagni si concentrano qui sulla composizione e sulla componente emozionale per approdare ad una release che funge da passepartout per l’Olimpo dei grandi.
Se c’è un difetto da riscontrare in “Innuendo”, oltre ad una cura minore in fase di produzione rispetto a “The Miracle”, annoveriamo senz’altro un certo patetismo di fondo, da cui i Queen non sono mai stati esenti, certo, ma che acquista una luce sinistra nel contesto di un dramma reale come la malattia di Mercury, ormai in stadio avanzato. E’ per questo che The Show Must Go On, il brano forse più prevedibile della raccolta, assurge a manifesto dell’intero album, e, per alcuni, dell’intera carriera della band: la stampa ricama su un testo poetico e struggente, sugli acuti desolati di Freddie, e quando, il 24 Novembre 1991, il cantante esala l’ultimo respiro, si scatena un circo mediatico di lega infima (ad un’edizione in vinile del “Freddie Mercury Tribute”, tenutosi anni dopo con la partecipazione di stars internazionali, venne perfino allegata una foto del piede di Mercuri, scattata direttamente all’obitorio, con tanto di cartellino identificativo).
Ad ogni modo, tralasciando queste pur inevitabili considerazioni extramusicali, rimane un peccato che l’intero album venga oscurato dalla pur magnifica overture omonima. Molti altri brani, non a caso poi ripresi nel celeberrimo “Greatest Hits II”, meritano la menzione: il lirismo sinuoso di I’m Going Slightly Mad, l’ingenuità corale di I Can’t Live With You, il gospel terreno di All God’s People…per non parlare di Bijou e Don’t Try So Hard, schegge di diamante luminose e perfette che allontanano definitivamente i Queen dal glam-rock degli inizi.
“Innuendo” è un album pomposo, ben costruito e sicuramente ambizioso: in fin dei conti, seppur in alcuni episodi il gusto per la bigiotteria trash riappare (Delilah), lo scopo dei quattro può dirsi raggiunto.
Carlo Crudele
Made In Heaven (1995)

Ammetto di avere atteso sotto la pioggia l’apertura del pusher per questo disco: un fan è sempre un fan, e, pur dopo tanta inutile bagarre, la speranza è l’ultima a morire.
Ricordo pure che l’emozione è stata forte: “Made In Heaven”, a livello di suoni, è un disco che rasenta la perfezione, con la voce di Mercury in full bloom e un missaggio da urlo. Poi però, passata la sbornia di nostalgia, il disco rivela tutta la sua pochezza: la band, pur con tutte le sessions “mitiche” ancora da rivelare (tra cui quella con Michael Jackson, ormai divenuta leggenda metropolitana), sceglie di remigare, risuonare, riarrangiare e/o riacconciare brani in gran parte già editi come singoli. C’è I Was Born To Love You, pezzo già edito nel esordio da solista di Freddie che contiene a sua volta una traches di Going Back; c’è la title-track, già edita dai Cross di Taylor: c’è Too Much Love Will Kill You, presente anche in “Back To The Light” di May (e premiata col premio Campiello)…per non parlare di episodi imbarazzanti quali Let Me Live, uno dei pochi originals cantato da tutti e quattro i membri della band perché, si dice, non ci fu tempo per registrare interamente le parti vocali di Mercury.
“Made In Heaven” è un calderone con molti ingredienti indigesti, in cui è impossibile non notare una triste tattica commerciale per sfruttare al massimo il gonfio portafogli dei fans accaniti: non tutto viene per nuocere, certo – si pensi alla bellissima A Winter’s Tale, l’ultimo brano scritto da Mercury – ma appare decisamente troppo poco per poter giustificare un album del genere.
Carlo Crudele
Queen Rocks (1997)

C’era bisogno di “Queen Rocks?”.
Chiariamolo subito: probabilmente no, ma non importa.
Va detto che la scelta di allestire una tracklist di pezzi più “rock” e duri, risulta abbastanza originale; il songlisting non appare frustrato da intenzioni cronologiche ma è snellito dalla presenza di pezzi non scontati o necessariamente stranoti, come Put Out The Fire o I’m In Love With My Car (cantata da Roger Taylor).
Il disco risulta dunque piacevole, pungente il necessario, e sufficientemente fresco grazie appunto ad una miscela intelligente del tutto.
Facile individuarne altresì i punti deboli: come ogni medaglia ha il suo rovescio e una compilation simile non concede all’ascoltatore occasionale una veduta d’insieme delle varie anime del gruppo, regalando solo uno sguardo ai pezzi più “heavy” della carriera dei quattro. Inoltre, aleggia una pesante sensazione di “già sentito”, sofferta nonostante la scelta ‘agile’ delle canzoni; i pezzi firmati May, ben dieci dei diciotto in scaletta, lasciano poi pensare che il vecchio Brian abbia pensato più al proprio ego che ad una giusta ripartizione del minutaggio tra lui e il trascurato Freddie.
Infine “Queen Rocks” non costituisce purtroppo una valida alternativa ai più famosi “fratelli maggiori”, “Greatest Hits I, II & III”.
Peccato anche per il pezzo finale usato per promuovere il disco, No-One But You (Only The Good Die Young), stucchevole pastoral-corale di maniera che con il rock non c’entra nulla.
E neppure con i Queen.
David Tozzo
Greatest Hits I, II, III (1981, 1992, 1999)

I “Greatest Hits” nella discografia dei Queen hanno sempre ricoperto un ruolo del tutto particolare.
Accolti come dei piccoli eventi all’uscita, rimangono gli episodi più noti (oltre che venduti) e a loro modo pregiati tra gli altri dischi del gruppo, senza patire la bollatura di volgare “operazione commerciale”, pur essendo null’altro che quello in origine.
Ciò che rende “grandi” queste compliations? Semplicemente le “hits”.
Ci sia perdonato il gioco di parole, ma qui si ha inequivocabilmente a che fare con una serie di pezzi che definire dei classici è un semplice atto di giustizia. Anche chi non ama i Queen ne potrà riconoscere la pregevolezza e la qualità di un songwriting quanto mai irrispettoso verso le ingiurie del tempo (i “Greatest Hits” coprono un arco di tempo di bel quattro lustri).
Basta dare un’occhiata ai pezzi inclusi: da Bohemian Rhapsody (vero e proprio anthem “Queeniano”) a The Show Must Go On (struggente preludio della fine di Freddie, e sorta di auto-requiem), passando per Somebody To Lovee It’s A Hard Life, Killer Queen e Innuendo.
Stupisce l’estrema riconoscibilità di tutto il materiale, la facilità con cui si riconducono queste canzoni, anche molto diverse tra loro, al marchio Queen, e certamente non solo per l’inconfondibile vocalità del loro leader.
Basta una parola insomma per questi Greatest Hits: imprescindibili. Inutile invece il terzo capitolo della serie, che raschia il fondo del barile con una racoclta di remix (ottimo Under Pressure, per la verità) e pezzi da solista di Mercury.
David Tozzo
In Nuce (1996)
“In Nuce” non è un album “ufficiale” dei Queen: piuttosto, si tratta di una raccolta ben fatta di brani antecedenti alla costituzione del gruppo che ai completisti farà bene avere sotto mano. I riflettori sono giustamente puntati soprattutto su May e Taylor, mentre voce e basso sono ad opera di Tim Staffell, leader di quegli Smile dalle cui ceneri nacque proprio la Regina.
Dovendo emergere dal mare di bootlegs più o meno interessanti che da sempre girano sulla band, la Milestone parte però con tre brani misconosciuti cantati da Mercuri: Going Back ed I Can Hear Music sono cover divertenti e ben eseguite dai Larry Lurex (ovvero i Queen ancora in cerca di un nome), mentre Mad The Swine è un ottimo inedito che verrà incluso (in una versione di migliore qualità, ma sostanzialmente identica) nell’edizione americana del disco di esordio.
Paradossalmente, però, le sorprese vengono dai cinque brani seguenti: a dispetto del nome, gli Smile vatnavano infatti un approccio più meditato e composito alla materia musicale, che portava a brani che puntavano meno sull’impatto scenico e più sul sound.
Si notano comunque molte somiglianze con i futuri Queen, anche perché May già allora si curava della composizione al fianco di Staffell, che riservava buone sorprese soprattutto al basso: in brani come April Lady e Polar Bearmolto appartiene alla cultura seventies, ma la sua creatività istintiva e sicura sarebbe stata di certo preferibile al pur dignitoso Deacon.
Dopo una divertente Step On Me tinta di blues, chiude le danze Blag, pastiche di suoni molto sperimentale di cui più parti saranno poi riprese nei primi brani della band di Mercury.
Il risultato è un disco le cui fresche intuizioni compensano spesso la carente qualità sonora.
Carlo Crudele
Articolo di Carlo Crudele, Marco Iannini, Luca D’Alessandro, David Tozzo per Musicboom