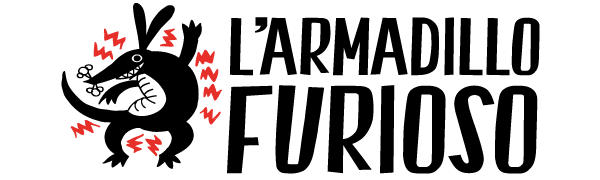INFORMATIVA PRIVACY
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, L’Armadillo Furioso rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. Lo scopo dell’informativa privacy è di garantire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e come le usa.
L’Armadillo Furioso tratta i dati in base al consenso. Con l’uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compresa l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, l’Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (tramite il link Contatti). Tuttavia negare il consenso può comportare l’impossibilità all’erogazione di alcuni servizi e l’esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere compromessa.
A partire dal 25 maggio 2018, data di entrata in vigore del GDPR, il presente sito tratterà alcuni dei dati in base ai legittimi interessi del titolare del trattamento.
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:
– indirizzo internet protocol (IP);
– tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
– nome dell’internet service provider (ISP);
– data e orario di visita;
– pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
– eventualmente il numero di click.
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza. A partire dal 25 maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare.
Per finalità di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo Ip, che potrebbe essere utilizzato, in conformità alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato.
Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti (dal 25 maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare).
Qualora il sito consenta l’inserimento di commenti, oppure in caso di specifici servizi richiesti dall’utente, il sito rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell’utente, compreso l’indirizzo mail. Tali dati si intendono volontariamente forniti dall’utente al momento della richiesta di erogazione del servizio. Con l’inserimento di un commento o altra informazione l’utente accetta espressamente l’informativa legata alla privacy, e in particolare acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente diffusi anche a terzi.
I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del servizio.
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente consapevolmente e volontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali.
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate. In ogni caso i dati rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.
I dati utilizzati a fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del sito) sono conservati per 7 giorni.
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del web Hosting. Il web hosting (Tophost S.r.l. a socio unico – Piazza della Libertà, 10– Roma), che è responsabile del trattamento dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee.
Cookie
Come è d’uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito) e per l’analisi dell’uso del sito.
I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili per evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita all’utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza per impedire attacchi informatici al sito.
I cookie di sessione non contengono dati personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi non occorre consenso.
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l’uso del sito, in particolare sono collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte dell’utente (come il Login), per i quali non occorre alcun consenso.
I cookies sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookies. La disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies sono le seguenti e possono essere trovate anche pagine web ufficiali dei browser.
Microsoft Internet Explorer
Clicca sull’icona ‘Strumenti’ nell’angolo in alto a destra e seleziona ‘Opzioni internet’. Nella finestra pop up seleziona ‘Privacy’. Qui potrai regolare le impostazioni dei tuoi cookies.
Google Chrome
Clicca sulla chiave inglese nell’angolo in alto a destra e seleziona ‘Impostazioni’. A questo punto seleziona ‘Mostra impostazioni avanzate’ e cambia le impostazioni della ‘Privacy’.
Mozilla Firefox
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra seleziona ‘Opzioni’. Nella finestra di pop up seleziona ‘Privacy’. Qui potrai regolare le impostazioni dei tuoi cookies.
Safari
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra seleziona ‘Preferenze’. Seleziona ‘Sicurezza’ e qui potrai regolare le impostazioni dei tuoi cookies.
Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting, visita www.youronlinechoices.com.
Cookies di terze parti
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito stesso, come i pulsanti per i social, oppure video. Questo sito non ha alcun controllo sui cookie delle terze parti, interamente gestiti dalle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni sull’uso dei detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l’eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito.
In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti:
– Google Analytics: uno strumento di analisi di Google che attraverso l’uso di cookies (performance cookies), raccoglie dati di navigazione anonimi (IP troncati all’ultimo ottetto) ed esclusivamente aggregati allo scopo di esaminare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività nel sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo Ip a nessun altro dato posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati Uniti.
In base a specifico accordo con Google, che è designato quale responsabile del trattamento dei dati, questi si impegna a trattare i dati in base alle richieste del Titolare (vedi in fondo all’informativa), impartite tramite le impostazioni del software. In base a tali impostazioni le opzioni pubblicitarie e di condivisione dei dati sono disattive.
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie Usage on Websites.
L’utente può disabilitare in modo selettivo la raccolta di dati da parte di Google Analytics installando sul proprio browser l’apposito componente fornito da Google (opt out).
– Youtube: una piattaforma di proprietà di Google, per la condivisione di video, che utilizza cookie per raccogliere informazioni degli utenti e dei dispositivi di navigazione. I video presenti nel sito non veicolano cookie all’accesso della pagina, essendo stata impostata l’opzione “privacy avanzata (no cookie)” in base alla quale YouTube non memorizza le informazioni sui visitatori a meno che essi non riproducano volontariamente il video.
Per ulteriori informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere visione delle informazioni all’apposita pagina predisposta da Google, e alla pagina sulle Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o app dei partner.
Plugin Social Network
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l’utente fa effettivo e volontario uso del plugin.
Si tenga presente che se l’utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell’iscrizione al social network.
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield – qui la pagina informativa del Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.
Diritti dell’utente
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
– richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
– conoscerne l’origine;
– riceverne comunicazione intelligibile;
– avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
– richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
– nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
– il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina del Garante);
– nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti degli interessati al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in particolare il diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è l’amministratore del sito, Francesco Bove, contattabile a redazione@armadillofurioso.it per chiedere l’esportazione o la cancellazione dei dati personali.