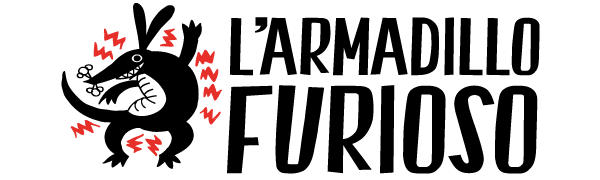Antonello Cossia: bisogna ripristinare l’urgenza creativa – seconda parte
Seconda parte dell’intervista ad Antonello Cossia
6) Le due misure più estreme ed urgenti da mettere in atto, secondo te/voi?
Ritornare ad occuparsi delle realtà più piccole, dare forza alla media imprenditoria, tornare a diffondere il teatro in scala nazionale, non solo quello legato ai grandi nomi ma anche le compagini deboli in termini produttivi.
Fare in modo seriamente che le risorse di un teatro Nazionale ricadano sul territorio in forma diffusa, ampia, reale e soprattutto con una maggiore turnazione delle forze in campo.
In ordine di urgenze ne aggiungo una terza, non ultima, importante: formare dei veri organizzatori, degli esperti in marketing, promozione e naturalmente più di tutto, far rinascere la distribuzione.
Figure totalmente assenti alle nostre latitudini. Dove l’attore/regista per far fronte alla mancanza di diffusione e realizzazione del proprio lavoro è obbligato a trasformarsi in produttore, organizzatore, addetto stampa, direttore tecnico e rappresentate legale, con tutto il resto che ancora c’è intorno.
7) Ha ancora senso mettere in scena i classici? O andrebbero “tolti di scena”? Quanto influisce la scelta politica di un direttore artistico?
Andrebbe ripristinata a mio parere l’urgenza creativa, la necessità, il motivo fondante grazie al quale si pensa di avere qualcosa da dire attraverso il teatro. Non si avrebbe più questa insana distinzione tra i classici, i contemporanei, la commedia, il dramma e così via. Ma va naturalmente trasformato il contesto, siamo allo stesso punto di prima. In Germania, Spagna, Francia, questo discorso è già superato.
Ho visto al festival teatro Italia una versione di – Un nemico del popolo – di Ibsen per la regia di Thomas Ostermeier che nonostante la fedeltà al testo originale del mille ottocento ottantadue, avrebbe molto da dire ed insegnare a tanti drammaturghi contemporanei…
Così come ho visto spesso la noiosa attitudine di aggrapparsi saldamente ad un testo classico senza alcuna capacità di rivitalizzarlo, riportarlo in vita, ‘alzarlo dalla pagina’, come si dice in gergo…
Le scelte di un direttore artistico sono importanti poiché dettano la linea di proposta di un teatro. Sarebbe possibile essere più ampi e variegati nella proposta di cartellone? In Umbria, in Toscana, in Emilia Romagna, nel 1989 giravamo con una creazione di Antonio Neiwiller, dedicata a Joseph Beuys , insieme a Steve Lacy dal vivo in cartelloni con Glauco Mauri, Paolo Poli… Lo spettatore riceveva l’ampio raggio della proposta artistica attiva in Italia in quel momento.
Il mezzogiorno, non si capisce perché, con l’enorme potenziale che ha, è fermo a dinamiche da Regno delle due Sicilie, prosa, danza, ricerca, commerciale… che noia le etichette.
Passerei all’ottava domanda.
8) Si può parlare di “dittatura teatrale” nel mondo delle arti in scena? Se sì, perché?
Per indole personale e formazione teatrale, credo poco nelle esperienze basate su quella che indichiamo come “dittatura al comando” nello sviluppo e articolazione di un progetto. Figuriamoci se affrontiamo l’ambito artistico, il valore che può avere per me un simile concetto. Pongo totale fiducia in un processo di lavoro aperto, condiviso, partecipato da tutte le componenti che ne fanno parte. Certo se intendiamo la responsabilità del coordinamento nel delineare l’andamento del lavoro, allora le mie idee in proposito sono abbastanza chiare.
“Il teatro è la ciurma di una nave” scriveva Vesevol’d Mejerchol’d negli anni 1913/17 nell’ambito del suo percorso portato avanti nello studio di via Borodinskaja, luogo di approfondimento e ricerca della sua arte teatrale. Seguendo questa metafora io vado subito con la mente all’equipaggio degli Argonauti, dove Giasone era un ‘primus inter pares’, tra i cinquanta semidei dell’equipaggio.
Ciascuno era necessario alla forza dell’insieme, ma naturalmente ognuno sapeva ben svolgere le sue mansioni per condurre a buon fine il viaggio da una meta all’altra. Come su di una barca a vela, dove c’è il capitano e nessuno si sognerebbe in regata di riflettere o argomentare su una indicazione data, in special modo mentre il vento soffia forte.
Dopodiché si può dire che la storia del teatro è stato un continuo sovvertimento dei maestri in una crescita e sviluppo di enorme ricchezza per le tecniche e le idee che si andavano affermando in un gioco di superamento e avvicendamento.
L’esperienza russa del novecento e delle avanguardie, ce lo racconta bene.
In Italia tra gli anni ’30 e ‘40 cominciano ad affermarsi figure di notevole importanza, come Silvio D’Amico, Anton Giulio Bragaglia, Luchino Visconti, fino a Giorgio Strheler ai giorni nostri, per contrapporsi alla presenza ingombrante del mattatore che incentrava su di sé tutta l’importanza dell’evento scenico, trascurando spesso il resto.
Ecco che però nella stagione dei cambiamenti a fine anni ’60 gli attori rivendicano una loro autonomia ed abbiamo quella che fu denominata ‘la rivolta degli attori’ con Enrico Maria Salerno, Vittorio Gassman, Tino Buazzelli, Sergio Fantoni, Romolo Valli.
Insomma un continuo incessante, circolare sovvertimento al comando, che devo dire però per quanto mi riguarda ha prodotto innovazioni e trasformazioni.
Io ho vissuto una esperienza di gruppo in cui tutti riconoscevamo in Antonio Neiwiller lo spessore e l’autorità spirituale per guidarci attraverso gli impervi territori della ricerca e della creazione.
Si può avere a livello più ampio ed elevato un forte riferimento nella esperienza di Julian Beck con il Living Theatre, Jerzy Grotowski, Peter Brook e diversi altri maestri.
Oggi mi piace condividere e partecipare al concetto espresso e praticato in maniera notevole da Toni Servillo, relativa al regista come direttore d’orchestra, un primo violino tra violini, ma anche ricordare il grosso rispetto e l’autonomia dell’attore-autore, sotto una attenta coordinazione del regista, così come fa Mario Martone. Il gruppo, l’equipe per dirla alla francese, premia la qualità del lavoro.
Insieme si va verso la meta, che altro non è se non l’offerta di un evento teatrale di alta qualità agli spettatori, accompagnato da una crescita e un miglioramento dei rapporti professionali congiunti a quelli fondamentalmente umani.
9) È possibile un “teatro della crisi” in cui artisti, spettatori e critica trovino un punto in comune?
10) Quant’è importante lo spettatore a teatro? Quanto è necessario investire nella formazione di un pubblico consapevole?
Prima di salutarti, ringraziandoti per la collaborazione, ti chiediamo un’ultima riflessione: qual è la tua missione teatrale? Come immagini la situazione culturale e teatrale italiana nei prossimi cinque anni?
“Colui che vuol comprendere quello che motiva gli uomini, non è interessato dai simboli trascendenti, senza il riso, senza le lacrime, senza un poco di calore e un poco di musica, gli esseri umani non trovano affatto un tornaconto. In fondo quello che bisogna fare è soddisfare queste esigenze tutte insieme in seno allo stesso avvenimento. Come fare? E’ così che le persone di teatro constatarono nel tempo, che qualunque sia la natura del problema, bisogna necessariamente riferirsi continuamente alla grande e profonda parola: “INTERESSANTE”.
Si concludeva così una bella leggenda a proposito della parola INTERESSANTE, che mise in accordo tutte le persone che a vari ambiti e in ruoli diversi, vennero coinvolte nella invenzione del teatro da parte di Dio, dopo la creazione del mondo.
Essa è riportata da Peter Brook, sul programma di sala di un suo spettacolo al festival di Avignone nel 1978 – Misura per Misura. E ancora Peter Brook nella sua biografia – I fili del tempo – edita da Feltrinelli:
“In tanti anni di esperimenti e di errori imparammo che è più importante sviluppare una sensibilità nei confronti dell’altro e del pubblico che realizzare il proprio desiderio di esprimersi”.
Il punto in comune a mio avviso va cercato in questo termine appunto, interessante, inteso però nel senso più profondo, relazionale e vero di avere reciproci elementi di condivisione, di domanda, di tensione vitale, di desiderio di interrogarsi sulle cose della vita, ma anche di godere del suo mistero che a teatro dovrebbe trovare la sua massima possibilità di esplorazione.
‘Bisogna liberarsi dall’oppressione e riconciliarsi con il mistero’. Scriveva Antonio Neiwiller in quello che in generale è considerato una sorta di testamento dopo la sua morte.
Io personalmente gli ho sempre sentito dire queste cose e le ho avvertite nei suoi spettacoli, sia prima che durante la mia esperienza personale con lui dal 1987/88 fino al 1993 anno della sua prematura scomparsa.
Certo la lotta è molto dura in questi tempi di invasività delle comunicazioni, di distrazioni, di eccessi di informazione che altro non fanno se non aumentare lo spaesamento e la confusione.
Bisogna tendere a recuperare l’umano, pur rischiando di sbagliare, di commettere errori di ingenuità, ma tornare alle persone, alle relazioni e non al “così vanno le cose a questo mondo”…
L’utopia che mi viene da esprimere pubblicamente, oltre le ambizioni sane e i desideri di miglioramento personali, è quella legata all’amministrazione della cosa pubblica, degli strumenti di diffusione del sapere, della conoscenza, la scuola, il credere nello specifico, peculiare, personale operato, contro il generalissimo ‘così fan tutti’ che impera incontrastato nella morale dei nostri tempi.
Solo creando un sistema civico virtuoso e a misura di cittadino, sulla base delle reali esigenze, si potrà avere la libertà, la possibilità, il tempo qualitativo di interrogarsi sui grandi sentimenti, di sorridere delle miserie umane evitando di perpetrarle tra i propri simili, di indagare i misteri della vita, di porsi le grandi domande che esaltano le facoltà dell’intelletto e della sensibilità umana.
Io personalmente, qualche anno fa, insieme ad alcuni cari compagni di viaggio, Paolo Cresta, Riccardo Veno, Antonio Cossia, a cui si aggiunge in forma assolutamente partecipe e condivisa, ma non costitutiva Raffaele Di Florio, insieme a loro appunto, ho creato una associazione culturale che porta il nome Altrosguardo, dopo dieci anni di condivisione artistica identificata nell’operato e nella realizzazione di molti spettacoli che portavano la firma CossiaDiFlorioVeno, tra il 1992/93 e il 2002/04. Anni in cui il gesto creativo seppur inciso negli occhi e nei cuori degli spettatori, si è disperso strutturalmente, non disponendo all’epoca di una solida organizzazione, giunta in piccolo e dopo tempo, grazie all’operato di una persona che specificamente e in forma qualitativamente e professionalmente all’altezza, si occupa di tutta la parte burocratica, amministrativa, organizzativa, Giusi Langella appunto.
In un certo senso è come se si fosse ripartiti daccapo, come se tutto quello fatto prima, non essendo sistematicamente registrato e archiviato in modalità fiscali, non fosse mai esistito.
Per fortuna la memoria, altro grande tesoro del teatro, unita al lavoro di alcuni critici attenti, di tanto in tanto qualche sparuto articolo di giornale, testimoniano un vissuto da palcoscenico degno delle avanguardie di quegli anni.
Non disponendo di grandi mezzi produttivi siamo costretti a concentrare su un piccolo ensamble la realizzazione di idee e progetti che per fortuna non mancano, a fronte dell’assenza di veri produttori, operatori, programmatori interessati.
La mia missione personale all’interno di questa compagine si è materializzata in alcuni spettacoli su temi vieppiù diversi, ma sempre in qualche modo legati a ciò che mi circonda, a cui appartengo, di cui faccio parte pienamente: Gli anni che precedono il boom economico, per indagare il contesto che generazionalmente ha preceduto il mio, indagati in – A fronte alta, un sogno del 1956.
La follia, l’istinto, l’animalità vissuta attraverso l’esperienza de – La camera scura, i dubbi e le perplessità di un padre che attende un figlio in – Ultime notizie dalla famiglia. La tragedia dei migranti clandestini portata e affermata duramente in scena con – Solo andata.
Insomma il mio pensiero si, ma soprattutto ciò che sento anche intorno a me, ascoltando, osservando, riflettendo grazie alle persone, agli sconosciuti, al flusso di una città teatro a cielo aperto come qualcuno ebbe a definirla.
Questo è il processo personale, per fortuna il teatro è la più ricca e variegata forma di democrazia ancora possibile ed esistente al mondo, fino a quando non sarà schiacciata e disintegrata definitivamente dall’economia e dal più bieco e cieco potere, che vede in questa possibilità una forza che attraverso il pensiero si potrebbe trasformare in azione eversiva positiva.
Non dimentichiamo che la rivoluzione francese, senza ora precisare la trasformazione e l’articolazione, è nata da un secolo di azione intellettuale: Diderot, Voltaire, Montesquieu e via dicendo…
Il pubblico dovrebbe anche avere la forza di decidere, difendere, innalzare i propri templi di sapere e di cultura, ma sin dai tempi degli antichi romani, grazie a Giovenale abbiamo imparato che il potere si gestisce molto meglio attraverso ‘Panem et circenses’, che con il legame e l’azione catartica che la tragedia greca assumeva nel rapporto tra i cittadini e il rispetto delle leggi e degli avvenimenti.
L’attenzione insomma deve essere alta, l’impegno sfiancante, la concentrazione continua, non per imporre, ci mancherebbe altro, ma quanto meno per sostenere e difendere un altro pensiero dell’esistenza, che seppur passa attraverso ombre e dubbi, tende comunque ad una felicità diffusa e egualitaria, dove non il ceto o l’economia debbano stabilire l’appartenenza ma la libertà e la possibilità di scelta, tenendo alto i concetti di rispetto, cooperazione, inclusione.
Quindi un teatro che possa essere anche causa di riflessioni diverse e di conflitti di pensiero tesi a superare e migliorare l’esistente, che abbia un elevato valore pedagogico e formativo in termini di pensiero e non di didattica, in termini di spirito e di libertà e non di accademismo e omologazione nascerà e sarà in salute nel momento in cui la società stessa lo valorizzerà e lo considererà un atto costante.
Senza dimenticare che in fondo il teatro ha sempre resistito, lottato, agito in seno a contesti che molto spesso lo rifiutavano e lo ignoravano come il peggiore dei mali. Un tempo gli attori venivano seppelliti fuori dalle mura. Ecco.
Mi sembra di aver risposto e so bene, non in forma sintetica, me ne scuso, alle ultime tre domande insieme. Allora è mio desiderio chiudere riportando proprio lo scritto di Antonio Neiwiller citato sopra. L’auspicio è che possa diventare spinta e sostegno per la ricerca di un ambito d’espressione, il quale riesca a contenere tutti i pensieri del mondo, nel bene e nel male, ma proprio per questo possa fornire gli strumenti per un miglioramento in pensiero ed azione, della società che ci circonda, almeno per i prossimi cinque anni, per chiudere sulla suggestione della previsione da voi chiesta.
Per un teatro clandestino. Dedicato a T. Kantor Antonio Neiwiller, maggio 1993.
È tempo di mettersi in ascolto.
È tempo di fare silenzio dentro di sé.
È tempo di essere mobili e leggeri,
di alleggerirsi per mettersi in cammino.
È tempo di convivere con le macerie e
l’orrore, per trovare un senso.
Tra non molto, anche i mediocri lo diranno.
Ma io parlo di strade più impervie,
di impegni più rischiosi,
di atti meditati in solitudine.
L’unica morale possibile
è quella che puoi trovare,
giorno per giorno
nel tuo luogo aperto-appartato.
Che senso ha se solo tu ti salvi.
Bisogna poter contemplare,
ma essere anche in viaggio.
Bisogna essere attenti,
mobili,
spregiudicati e ispirati.
Un nomadismo,
una condizione,
un’avventura,
un processo di liberazione,
una fatica,
un dolore,
per comunicare tra le macerie.
Bisogna usare tutti i mezzi disponibili,
per trovare la morale profonda
della propria arte.
Luoghi visibili
e luoghi invisibili,
luoghi reali
e luoghi immaginari
popoleranno il nostro cammino.
Ma la merce è merce
e la sua legge sarà
sempre pronta a cancellare
il lavoro di
chi ha trovato radici
e guarda lontano.
Il passato e il futuro
non esistono nell’eterno presente
del consumo.
Questo è uno degli orrori,
con il quale da tempo conviviamo
e al quale non abbiamo ancora
dato una risposta adeguata.
Bisogna liberarsi dall’oppressione
e riconciliarsi con il mistero.
Due sono le strade da percorrere,
due sono le forze da far coesistere.
La politica da sola è cieca.
Il mistero, che è muto,
da solo diventa sordo.
Un’arte clandestina
per mantenersi aperti,
essere in viaggio ma
lasciare tracce,
edificare luoghi,
unirsi a viaggiatori inquieti.
E se a qualcuno verrà in mente,
un giorno, di fare la mappa
di questo itinerario,
di ripercorrere i luoghi,
di esaminare le tracce,
mi auguro che sarà solo
per trovare un nuovo inizio.
È tempo che l’arte
trovi altre forme
per comunicare in un universo
in cui tutto è comunicazione.
È tempo che esca dal tempo astratto
del mercato,
per ricostruire
il tempo umano dell’espressione necessaria.
Bisogna inventare.
Una stalla può diventare
un tempio e
restare magnificamente una stalla.
Né un Dio,
né un’idea,
potranno salvarci
ma solo una relazione vitale.
Ci vuole
un altro sguardo
per dare senso a ciò
che barbaramente muore ogni giorno
omologandosi.
E come dice un maestro:
«tutto ricordare e tutto dimenticare».