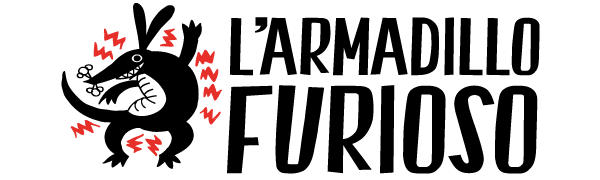Alessandro Toppi: il teatro costringe l’uomo al corpo-a-corpo con l’uomo
Alessandro Toppi ha quarant’anni da poco compiuti. Laureato in Storia del Teatro all’Università Federico II di Napoli, di teatro ho cominciato a scrivere per una scomparsa rivista chiamata Ateatro, sparita in meno di due anni, all’improvviso. Co-fondatore e direttore responsabile de Il Pickwick, redattore di Hystrio, ha scritto talora anche per I teatri della diversità. Autore delle prefazioni a Patres, di Saverio Tavano (La Mongolfiera Editrice, 2015) e Preamleto, di Michele Santeramo (Nardini Editore, 2016). Membro dell’ Associazione Nazionale Critici di Teatro e dell’Associazione Internazionale Critici di Teatro.
Se volessimo cominciare un’analisi della situazione della crisi culturale del teatro italiano, da quali segni dovremmo partire? Secondo te la crisi del teatro potrebbe essere la diretta conseguenza di una crisi generazionale, d’identità e di opportunità? Quali sono i tempi e i modi del suo sviluppo?
Partiamo da ciò che accade all’esterno dei teatri; proviamo per un attimo a scrivere di teatro osservando dove il teatro non c’è. Non c’è nella gran parte delle scuole italiane e non c’è né come disciplina né come opportunità ludica e formativa concreta; non c’è nei programmi di Italiano, espulso come non fosse fatto anche di autori e di testi, come se Pirandello – prima di essere lo scrittore di Uno, nessuno e centomila – non fosse stato anche e soprattutto il drammaturgo dei Sei personaggi; vivacchia in qualche Ateneo, certo, affidato com’è all’entusiasmo dei professori, ma raramente la Storia del Teatro o la Letteratura Teatrale sono insegnamenti fondamentali. Ancora: non c’è il teatro nel palinsesto generalista della televisione pubblica – diamine, cosa vi costa un sabato sera e una domenica pomeriggio? – e l’unico esempio virtuoso pre-Rai 5 (Palcoscenico) è morto di “mauriziocostanzite”, diventando un Palco e Retropalco che dava non più Cecchi o Ronconi ma Giobbe Covatta e il battutista di Zelig. C’è sempre meno teatro sulle pagine dei quotidiani; la morte di Pinter non è stata neanche accennata – quel giorno – dai telegiornali nostrani; le parola “teatro” è coniugata nel dispregiativo “teatrino” dalla e per la politica mentre il termine “attore” è conosciuto alla dignità retorica dei discorsi pubblici ma sconosciuto alla prassi effettiva delle scelte istituzionali. Non esiste, cioè, una civiltà teatrale in Italia; non è riconosciuta al teatro una funzione che non sia d’intrattenimento o “da valletta”; non c’è la comprensione e il riconoscimento comune del fatto che il teatro può e talora riesce ad essere lo specchio distorto e fedele di ciò che stiamo diventando come individui e in quanto collettività e, per questo, va considerato un fondamento del discorso pubblico e della nostra irrinunciabile natura sociale.
D’altronde: lasciata l’origine greca alle prime pagine dei manuali, quando teatro e teatranti non sono stati una minoranza costretta ai margini?
I Comici dell’Arte somigliavano ai mendicanti; al Globe si arrivava dopo aver superato cimiteri, discariche e prigioni; Vera Kommissarževskaja – la più bella attrice di Russia, coi suoi occhi «azzurri senza fondo» – tentò l’avanguardia di Mejerchol’d in un buco che divenne un pozzo di solitudine e fallimento; Beckett andò in scena avendo a disposizione un ramo secco e tre fari e le cantine, da Opole a Roma, sono pur sempre cantine. “Crisi” è la parola-chiave dell’intervista, giusto? E quale altro tentativo d’arte conosce la crisi – è fatto di crisi – più del teatro, che avviene spesso in condizioni materiali misere e che, quando scompare, lascia (forse) traccia di sé soltanto in chi l’ha veduto? E ancora, pensando all’attore, che ne è la sua espressione più esposta: non è, il suo, un continuo stato di crisi? Il suo mestiere è fatto di “crisi”: sono crisi le lunghe pause in cui non ha una scrittura, certo, ma è composto di crisi anche e soprattutto quando – giorno dopo giorno, nel chiuso di uno spazio adattato a sala prova – tenta/cerca un gesto, una frase, questo ruolo. Crisi muscolari ed emotive che sono il presupposto perché una sera esca dal retro, per dirci la prima parola del testo: sembrando sicuro di quel che pronuncia, pur non essendolo.
È generazionale? Non lo è, mi viene da scrivere pensando al “Teatro” con la maiuscola ed al Sempre e l’Ovunque cui esso appartiene. Diventa generazionale la “crisi” – in Italia, dov’è generazionale anche la crisi dei diritti e delle opportunità, della rappresentanza e del lavoro – non appena parliamo di Leggi, Decreti, Politiche.
Si può affermare che la crisi del teatro possa dipendere anche da una mancanza di idee teatrali forti?
Il teatro ha in sé un’idea fortissima: costringe l’uomo al corpo-a-corpo con l’uomo. Non lo fa la Letteratura, non lo fanno le Arti visive, non lo fa né il Cinema né la Televisione, ormai neanche più la Politica ha come presupposto, vincolo e forma l’incontro, la rappresentanza, l’atto comunitario. Nelle corsie di alcuni ospedali emiliani, toscani o laziali, non gira più il medico ma un robot che ne riporta l’immagine-Skype, le aziende si affidano a segretarie partorite da un computer e – in tangenziale – diamo le monetine a una macchina che ci augura “buon viaggio” con voce metallica e in quattro lingue diverse. Mediamo la nostra esistenza di continuo, interagiamo tra di noi senza toccarci, mostriamo un facebook del nostro aspetto e della nostra giornata, siamo presenti in assenza.
Il teatro ci costringe invece a guardare ed essere guadati, ad ascoltare, prestare attenzione, ad avere rispetto (nel silenzio) per la storia dell’altro e a comprendere – che questa storia – è anche la nostra. È un’educazione all’umano. Questa mi pare la sua idea forte, questo è il suo fondamento atavico, minoritario ed inattuale e – questo fondamento – mi sembra, ogni volta, resistente e rivoluzionario. Il resto sono poetiche (dalle marionette di Cuticchio al latino virgiliano di Anagoor passando per il corpo d’ogni attore che calca il palcoscenico), sono scelte espressive, lessico artistico con la speranza personale che il teatro non si de-teatralizzi rinunciando alla sua carnalità e alla sua imperfezione artigiana. Al Napoli Teatro Festival Italia ho visto di recente spettacoli che – in caso di blackout momentaneo – sarebbero spariti, non potendo tecnologicamente avvenire mentre a Troia, piccolo paese del foggiano, nel buio imprevisto (saltati i fari, assenti altre luci a parte le stelle) un’attrice ha continuato per più di dieci minuti a dire, dicendoci: ombra lei, ombre noi; tra lei e noi le parole. E d’altronde, Pindaro come definisce l’uomo se non “sogno di un’ombra”?
Qual è la funzione sociale del teatro oggi? Quali necessità soddisfa?
A Bolzano ragazzi con sindrome di Down, portatori e portatrici di handicap e interpreti normodotati hanno allestito Pirandello: prima hanno preparato per noi spettatori la sala, dopo l’hanno pulita e spazzata della loro stessa fatica attorale, dimostrandoci cosa significa aver cura del teatro. A Volterra i detenuti hanno lasciato la loro cella per il tempo di una recita o hanno fatto, con la recita, della loro cella l’isola de La tempesta; a San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli, i commercianti pagano il “pizzo culturale” a un teatro, il Nest, nato dall’occupazione d’una scuola in abbandono e che accoglie compagnie indipendenti e l’associazionismo di quartiere; nella traversa successiva – sempre a San Giovanni a Teduccio – un ferroviere, sua moglie ed alcuni suoi colleghi tengono aperto uno spazio minuscolo dove sono passati alcuni degli artisti più significativi della teatralità italiana degli ultimi vent’anni:è a Sala Ichòs che, ad esempio, Latini ha festeggiato l’Ubu con I giganti della montagna.
Per mesi ho seguito la Scuola Elementare di Iodice all’ex Asilo Filangieri, scoprendo la parità artistica tra due ragazzi autistici e degli attori in formazione il cui disagio era invisibile ma ugualmente presente; a Lamezia – città nella quale il teatro appartiene a mani private e affaristiche – Dario Natale e i suoi si occupano, da anni, dei più giovani e quanto sono importanti il CREST a Taranto o che a Castrovillari continui Primavera dei Teatri? Borrelli – adesso, mentre rispondo – sta aggregando persona a persona attraverso il culto della parola teatrale generando una comunità artisticamente impegnata nei Campi Flegrei: lì – a Bacoli, Baia, Torregaveta – dove un teatro inteso come edificio neanche esiste.
Sono gli esempi più facili per dire della capacità che ha il teatro di essere inclusivo, capace com’è di generare l’assieme, la coabitazione, una moltitudine: che sia più o meno estesa. Vale per loro, vale ogni volta che – di sera, quando la vita di una città rallenta e i cittadini sono portati a chiudersi in casa, sedendo davanti a un pc o a una televisione – un teatro accende le luci, invitando a scendere, percorrere strade, varcare una soglia, sedere in una platea: in un luogo nel quale cioè, ad un tempo, viene garantita e sottolineata l’unicità del tuo punto di vista sul mondo (la prospettiva che deriva dal posto in cui siedi) ma, questa unicità, è indotta a convivere con quelle degli altri.
Questa è la necessità che soddisfa il teatro, mi pare, e lo fa ancora di più quando riesce a far giungere dal palco una parola autentica, «cioè rivolta non soltanto al nostro orecchio ma al nostro animo, alla nostra mente, alla nostra coscienza», per dirla con Nicola Chiaromonte.
Si può credere a un rinnovamento del teatro o siamo in attesa di un modello culturale che possa scuotere le coscienze?
Lo Stato sostiene il teatro in Italia? Se sì ne beneficiano tutti?
Credo che il “rinnovamento” del teatro inteso come atto creativo passi per un cambio radicale dei suoi presupposti produttivi, organizzativi e distributivi. Come pretendere dalla generazione under di questo Paese nuove poetiche se – questa generazione – è priva del tempo e della possibilità della ricerca, di un tetto sopra la testa, se è limitata a tournée di quartiere, se non ha l’opportunità concreta dell’apprendimento, dello studio, del confronto formativo con Maestri e colleghi? E come pretendere la qualità della proposta artistica quando ogni pseudo-riforma della teatralità italiana è basata su criteri quantitativi, sull’innalzamento dei massimali, sulla vendibilità del prodotto finito?
Occorre mettere in condizioni migliori chi il teatro lo fa, dunque, e occorre generare un ricambio generazionale sul piano organizzativo perché possa accompagnare il naturale ricambio di autori, registi ed interpreti. Ma quale rinnovamento è possibile se le direzioni dei teatri pubblici dipendono dalle ultime elezioni? E quale rinnovamento può avvenire se i circuiti regionali smentiscono nei fatti le finalità espresse dai loro Statuti e se il Ministero – mentre modifica la distribuzione del FUS – riduce le possibilità di circuitazione ed avalla l’abitudine dello scambio teatrale?
Scrivo da Napoli e dalla Campania, ebbene: il direttore del Nazionale ha programmato l’ennesima stagione di classici affidati – fatte rare eccezioni – a registi della generazione di mio padre o mio nonno, cancellando del tutto (e in opposto a ciò che avviene all’estero) la presenza della drammaturgia contemporanea; al Ridotto – ovvero nello spazio che sarebbe destinato alla «ricerca di nuove forme sceniche» – da anni si programmano cicli dedicati alle parole del passato (da La Capria all’Ortese), chiedendo a chi se ne occupa solo un esercizio di stile. E il Teatro Pubblico Campano? Da trentatré anni è diretto dal suo fondatore e – pur essendo votato alla valorizzazione dei «più recenti linguaggi della scena» e «di ogni altra forma innovante di creazione d’arte» – ha proprio nel suo fondatore – ovvero in Alfredo Balsamo – un uomo che «si dichiara», cito da una ricerca effettuata dalla Scuola ‘Paolo Grassi’ di Milano (2003), «sinceramente non competente nelle scelte degli spettacoli di compagnie giovani e di danza».
Vogliamo continuare?
Il Napoli Teatro Festival Italia sceglie il suo direttore senza mai emettere un bando pubblico per cui continuano ad essere oscure le ragioni che determinano la nomina diretta (da Quaglia a Dragone). Mentre il Comune di Napoli non ha denaro da investire e non offre alcun servizio ai teatri urbani la Regione Campania ha appena stanziato 32 milioni per il teatro (Piano Operativo Complementare, fondi europei POC) distribuendoli a soli sette soggetti (San Carlo, NTFI, Ravello, Stabile di Napoli, Verdi di Salerno, Gesualdo di Avellino, Comunale di Caserta, Massimo di Benevento). Nessuna politica di residenza formativa o coproduttiva, nessun sostegno di sistema ai medio-piccoli spazi, nessuna idea su come rendere la legge regionale da norma di contributo a strumento d’investimento.
Com’è possibile che qui si generi davvero il nuovo? A prezzo di quali sforzi, attraverso che tipo di umiliazioni, accumulando quanto sacrificio e sconforto? Quanti debiti occorre fare? Quante volte occorre inchinarsi e quanto bisogna attendere prima che ciò che deve accadere accada davvero?
Chi ci crede e tenta lo fa con le proprie forze, non di rado cedendo nel tempo; la sensazione d’isolamento è forte; il bisogno di rimanere vivi impedisce o rende complessa la cooperazione tra operatori e/o tra gli artisti. Insomma, per citare Civica, l’opacità del sistema teatrale – e delle norme scritte e delle logiche non scritte che lo caratterizzano – porta «a rinchiuderci dentro di noi, a costruire una fortezza che tenga fuori la realtà e gli altri»: certo, «si continuano a produrre spettacoli, escono i cartelloni delle stagioni, si fanno festival teatrali ma c’è la sensazione di andare avanti per forza d’inerzia», secondo abitudini che – fatta salva la sopravvivenza personale – stanno perdendo di significato. «Ognuno si barrica nella propria fortezza vuota, sperando che passi la tempesta che c’è fuori».
Aggiungo.
È possibile che soltanto l’11% della quota-prosa del FUS sia stato destinato agli under 35? È possibile che una quota variabile tra il 70% e l’80% del finanziamento pubblico sia assorbito dalle spese della macchina gestionale e solo ciò che resta serva per gli attori e gli spettacoli? Ed è possibile che il Ministero finanzi il passivo di bilancio, suggerendo in questo modo di gonfiare le spese o di sperperare denaro? Ed è possibile, cito la Relazione della Commissione Prosa, che lo stesso Ministero favorisca in maniera progettuale «le imprese di dimensioni maggiori» e le «realtà chiaramente commerciali a discapito di realtà che sono focalizzate sul rischio artistico»? Possibile che l’uso del FUS sia determinato non solo «in maniera significativa da criteri quantitativi» ma che – questi criteri quantitativi – siano «frutto delle dichiarazioni degli stessi soggetti richiedenti» e che alcuni di questi dati siano palesemente «poco credibili» ma che non esistano reali strumenti «di controllo e verifica» perché siano denunciati come tali?
Le due misure più estreme ed urgenti da mettere in atto, secondo te.
Non tocca a me, non è il mio compito, non ho le capacità per offrire una risposta sensata.
Tuttavia, costretto a indicare qualcosa, direi: l’educazione alla teatralità fin dalle scuole primarie e – nel contempo – un’opera di formazione degli adulti che si occupano, nelle amministrazioni pubbliche, di teatro e cultura. Assessori comunali e regionali – e loro sottoposti – spesso sanno poco o nulla di teatro e teatri e pur tuttavia legiferano sul teatro e i teatri; non solo: non conoscono le esperienze utili e virtuose che avvengono nel proprio territorio ed altrove, non concretizzano pratiche d’ascolto reale degli operatori, non sanno prendere parte a un bando europeo, per favorire la progettualità in loco e/o una corretta gestione delle risorse disponibili; insomma: non sono competenti in materia.
Non a caso l’ex-assessore Antonella Di Nocera – durante le Giornate per la Cultura del 2013 – indicò come priorità «una riforma della macchina amministrativa» e, dunque, la possibilità di «sei mesi di stage a Bruxelles per trenta giovani funzionari del Comune e della Regione» perché formassero «una task-force interistituzionale con il compito di impedire che» andassero persi – o che venissero impiegati secondo logiche clientelari, amicali o privatistiche – «i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea».
Ha ancora senso mettere in scena i classici? O andrebbero “tolti di scena”? Quanto influisce la scelta politica di un direttore artistico?
Con Il giardino dei ciliegi di Benedetto Sicca – con questi giovani che appassiscono senza fare l’amore o battere i pugni – ho percepito la dannata comodità che avvolge la mia generazione, che risponde ai furti e ai debiti dei padri standosene distesa sul divano, canticchiando un motivetto qualsiasi; l’Amleto FX di VicoQuartoMazzini mi ha detto della fragilità che appartiene ai sedicenni che vedo fumare e bere per una notte intera in una piazza o una strada: maglia nera addosso, pallore truccato sul volto, nelle orecchie il Back to Black di Amy Winehouse; c’è Petito nelle creature periferiche di Punta Corsara, l’Otello innerva Le strategie fatali di Musella/Mazzarelli, Beckett suggerisce Due passi sono a Carullo/Minasi e giacciono nascosti Viviani e La serra di Pinter in alcuni versi di Mimmo Borrelli. Ciò che viene chiamato “classico” non smette di parlarci se non rinuncia a parlarci chi lo mette in scena e Molière o Eduardo possono dirci qualcosa di più vero e di urgente del drammaturgo che comporrà domani il suo testo. Rinunciamo forse a leggere Dostoevskij? Scacciamo dalla nostra libreria Dickens o Balzac? E Nabokov, Gadda, Saramago li consideriamo nostri contemporanei o già degli avanzi da sotterrare il più lontano possibile?
Per questo – e vengo ai direttori artistici – non servono gli allestimenti faraonici con cui i Nazionali fatturano i propri debiti, non servono cioè gli schermi delle autoproduzioni di De Fusco – ottimi per placare le smanie di protagonismo della sua primattrice – o lo sfoggio di orpelli del Candide di Arcuri, la grandiosità da allestimento lirico di Michieletto, lo sforzo visionario (intrasportabile e costosissimo) del Der Park di Peter Stein; serve «che la voce parlante e ragionante, ovvero anche esaltata e folle, del drammaturgo abbia il suo primo effetto sullo spettatore, parola per parola», ponendosi come una comunicazione umana, «diretta e intima» (Chiaromonte). E invece abbiamo perso la naturalezza del tono nudo dell’attore, mediato com’è da archetti, mosche e microfoni; siamo costretti a non guardare il volto di chi recita ma la sua proiezione in diretta o in differita in un video e, certe produzioni degli Stabili, sembrano divertirsi a fare di noi massaie o ragionieri: quanto diavolo sarà costata quella inutile scenografia?
Poi, certo, sui classici: forse occorrerebbe ampliare e diversificare il canone perché se è vero che con Shakespeare o Pirandello si ha la scusa per trascinare a teatro le scolaresche, che fanno numero per il Ministero e garantiscono la platea mezzo-piena in pomeridiana, mi viene anche da chiedere dove siano Marlowe, Bernhard, Koltès, Copi, Müller, Camus e tutti gli altri? E infine: di pari passo, coi “classici” la buona scrittura d’oggi, perché si generi una relazione costante: com’è possibile che Lo splendore dei supplizi di Fibre Parallele non sia entrato in alcun Nazionale, che non vi entrino (ad esempio) Deflorian/Tagliarini, Oscar De Summa, Aldrovandi o Santeramo? Non facciamo fare loro la fine che toccò come autore a Scaldati, cui il Biondo di Palermo concesse il palco grande solo da morto (sono ammessi, a questo punto, tutti gli scongiuri del caso da parte degli artisti citati…).
È possibile un “teatro della crisi” in cui artisti, spettatori e critica trovino un punto in comune?
Lascio rispondere Civica e Scarpellini con La fortezza vuota: «Gli elementi costitutivi elementari dell’arte scenica sono l’attore e lo spettatore. Gli elementi costitutivi della cultura teatrale sono l’artista, lo spettatore e il critico. Per riportare il teatro al centro della cultura occorre stabilire una nuova alleanza tra gli artisti, gli spettatori e la critica, basata sull’indipendenza e la non interscambiabilità delle loro funzioni all’interno di una stessa comunità di passioni. Per essere proficua questa alleanza va estesa a tutti quegli operatori disposti a inventare nuove strategie di sostegno economico al servizio di una scena fondata sul primato dell’arte e degli artisti».
Quant’è importante lo spettatore a teatro? Quanto è necessario investire nella formazione di un pubblico consapevole?
Io sono uno spettatore. Come potrei rispondere?